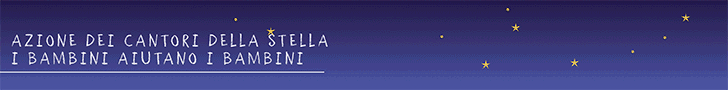Calendario romano
Luca 11, 1-13
Quando si parla di preghiera, come in questa XVII domenica del Tempo Ordinario, mi viene sempre in mente un brano del libro dei Re in cui il profeta Elia combatte con i profeti di Baal, che avevano diffuso il culto del Dio straniero in Israele. La scena è quasi grottesca, perché mentre gli adoratori in numero di 500 si sbracciano, danzano forsennatamente, si feriscono per omaggiare la divinità, il profeta da solo, dopo essersi preso gioco di loro, incitandoli ad urlare più forte, caso mai il loro dio fosse distratto o addormentato, si limita a parlare con pacatezza al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e il fuoco santo scende sui sacrifici, in segno di gradimento. Gesù non disdegna la festa, la danza, le manifestazioni di giubilo, per esempio quando entra in Gerusalemme, ma se deve insegnare ai suoi discepoli è molto più essenziale. Cosa rende autentica la preghiera, sobria o traboccante, nel segreto o nella pienezza dei gesti? Intanto, come sottolinea don Willy Volonté, la preghiera si impara, perché riguarda una relazione per la quale non basta una vita intera. Le formule sono la sedimentazione di una tradizione, portano con sé tutta la ricchezza di generazioni che hanno affinato nella forma la sostanza della fede, perché la preghiera è prima di tutto manifestazione ed espressione del nostro credo. Possono diventare sterili, se recitate come una magia, qualcosa che per sé stesso dovrebbe funzionare. Gesù non ha paura di insegnare una formula, una preghiera precisa, ricordata dagli evangelisti in due forme, sostanzialmente molto simili. Tuttavia basta ascoltarne le prime parole per capire che si va ben oltre l'aspetto formale: Padre nostro. Il termine usato da Gesù è Abbà, che significa papà, ma nella confidenza di un bambino. Questa è la preghiera, quando ci riconosciamo appartenenti nella figliolanza e il Padre si dona senza riserve. Questo è il grido che lo Spirito non cessa di innalzare dalla profondità del nostro cuore: Abbà, Padre.
Dante Balbo, dalla rubrica Il Respiro spirituale di Caritas Ticino su TeleTicino e su YouTube.
Calendario ambrosiano
Gv 6, 59-69
L’evangelo di questa domenica ci riferisce la reazione della gente e di molti discepoli alle parole dette da Gesù nella sinagoga di Cafarnao. Una reazione di rifiuto. Ma che cosa aveva detto Gesù di tanto urtante da provocare il rifiuto dei suoi ascoltatori che dicono: «Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?». Parole dure aveva pronunciato, così dure da determinare una vera e propria reazione di rigetto fino ad abbandonare Gesù: «Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono in[1]dietro e non andavano più con lui». Attorno a Gesù si fa il vuoto. Ma che cosa aveva detto? Aveva promesso di dare se stesso, la sua carne e il suo sangue come nutrimento e bevanda. E infatti gli ascoltatori si chiedono: «Ma come può costui darci la sua carne da mangiare?». La gente volta le spalle a Gesù che non fa nulla per trattenerli, non dà una interpretazione più tranquilla, anzi sembra invitare i discepoli ad andarsene se non sono pronti ad accogliere le sue parole, la sua sconvolgente promessa. Sarà Pietro, voce degli altri discepoli, a dire ancora una volta l’incondizionata adesione al Maestro e alle sue parole. Mi chiedo, infine, perché era così urtante il linguaggio di Gesù. Non dobbiamo dimenticare che i suoi ascoltatori avevano di Dio una nozione tanto elevata da non poter nemmeno pronunciare il suo nome, impossibile tentare di raffigurarlo, sarebbe stato un gesto idolatrico. Impossibile per l’animo ebraico congiungere il Dio altissimo e invisibile per l’occhio umano, con un modesto pezzo di pane. Vi è in questo rifiuto da parte degli ascoltatori di Gesù un valore che dobbiamo raccogliere; il pane che riceviamo sul palmo della nostra mano rispondendo Amen non è una cosa, per quanto sacra e preziosa, di cui possiamo disporre: è la Sua presenza, è il gesto di mettersi ancora una volta nelle nostre mani. Linguaggio duro per le pretese della nostra intelligenza, eppure, ripetiamo con Pietro, Parola di vita eterna.
don Giuseppe Grampa