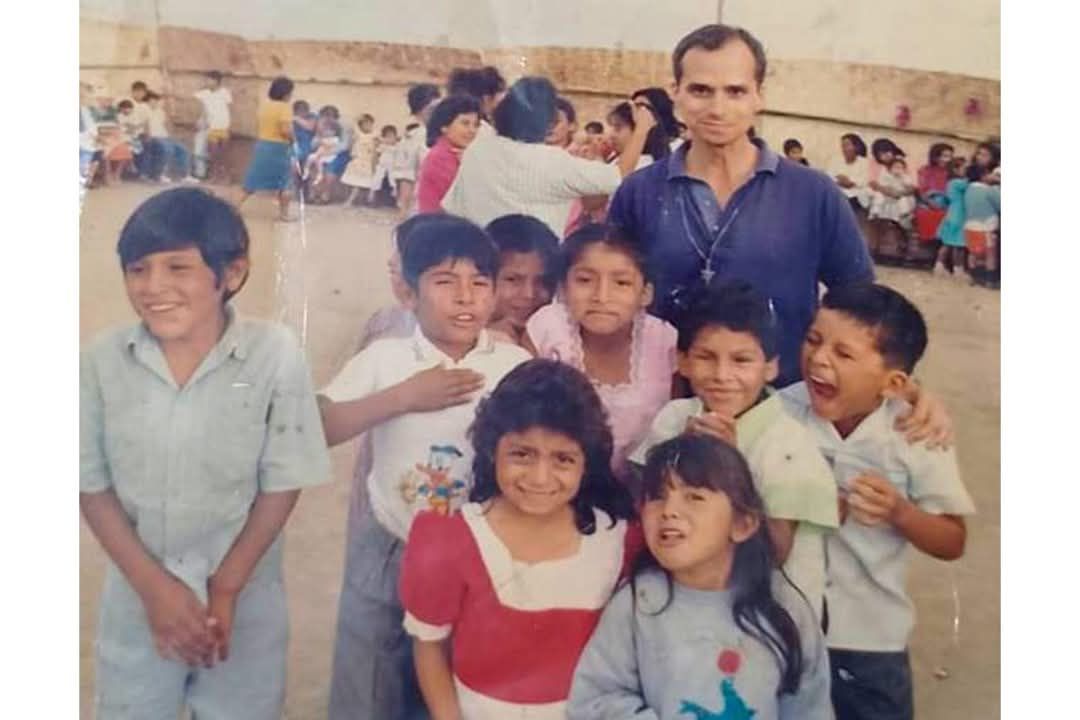«Il primato deve essere esercitato in un modo sinodale, e la sinodalità richiede il primato». Così il cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani sintetizza uno dei punti nodali del documento ecumenico intitolato “Il Vescovo di Roma”, reso noto giovedì 13 giugno. Un testo che sintetizza gli sviluppi del dialogo ecumenico sul tema del primato e della sinodalità.
Eminenza, ci può spiegare innanzitutto che cos’è questo documento, come nasce e qual è il suo scopo?
Questo documento, intitolato Il Vescovo di Roma, è un testo di studio che offre una sintesi dei recenti sviluppi ecumenici sul tema del primato e della sinodalità. La sua genesi risale all’invito rivolto a tutti i cristiani da San Giovanni Paolo II nella Ut unum sint a trovare, “evidentemente insieme”, le forme in cui il ministero del Vescovo di Roma “possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli altri”. Questo invito è stato più volte ribadito da Papa Benedetto XVI e da Papa Francesco. Il documento riassume una trentina di risposte a questo invito e una cinquantina di testi di dialoghi ecumenici sul tema. Nel 2020, il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani ha visto nel 25° anniversario dell’enciclica Ut unum sint un’opportunità per fare il punto della discussione. La convocazione di un Sinodo sulla sinodalità ha confermato la rilevanza di questo progetto, come contributo alla dimensione ecumenica del processo sinodale.
Quale metodologia è stata utilizzata per realizzare di questo documento?
Il documento è il risultato di un vero e proprio lavoro ecumenico e sinodale. Nella sua realizzazione ha coinvolto non solo gli officiali, ma anche i membri e i consultori del Dicastero che lo hanno discusso in due assemblee plenarie. Sono stati consultati molti esperti cattolici e numerosi studiosi di varie tradizioni cristiane, d’Oriente e d’Occidente, in collaborazione con l’Istituto di Studi Ecumenici dell’Angelicum. Infine, il testo è stato inviato a vari Dicasteri della Curia romana e alla Segreteria generale del Sinodo. In tutto, sono stati presi in considerazione più di cinquanta pareri e contributi. Il nostro documento tiene anche conto degli ultimi interventi nel quadro del processo sinodale.
Nell’enciclica Ut Unum sint (1995) Giovanni Paolo II si era detto disponibile a discutere le forme di esercizio del primato del Vescovo di Roma. Quale cammino è stato percorso in questi tre decenni?
La questione del primato è stata intensamente discussa in quasi tutti i contesti ecumenici negli ultimi decenni. Il nostro documento segnala i progressi ed evidenzia il fatto che i dialoghi teologici e le risposte all’enciclica testimoniano un nuovo e positivo spirito ecumenico nella discussione. Questo nuovo clima è indicativo delle buone relazioni instaurate tra le comunioni cristiane, di quella “fraternità ritrovata” della quale parla la Ut unum sint. Si può affermare che i dialoghi ecumenici si sono rivelati il contesto appropriato per discutere questo tema sensibile. In un’epoca in cui i risultati dell’impegno ecumenico sono spesso considerati scarsi o insignificanti, gli esiti dei dialoghi teologici dimostrano il valore della loro metodologia, cioè di una riflessione fatta “evidentemente insieme”.
Leggendo il documento colpisce innanzitutto la crescita di un consenso che si è riscontrato nei diversi dialoghi ecumenici circa la necessità del primato. Ciò significa che per le altre Chiese cristiane il ruolo del Vescovo di Roma non è più percepito soltanto come un ostacolo all’unità?
Nel 1967, Paolo VI affermava che “il Papa [...] è senza dubbio il più grave ostacolo sulla via dell’ecumenismo”. Tuttavia, cinquant’anni dopo, la lettura dei documenti di dialogo e delle risposte alla Ut unum sint attesta che la questione del primato per tutta la Chiesa, e in particolare del ministero del Vescovo di Roma, non è più vista solo come un problema, ma piuttosto come un’opportunità per una riflessione comune sulla natura della Chiesa e della sua missione nel mondo. Inoltre, nel nostro mondo globalizzato, indubbiamente vi è un crescente senso della necessità di un ministero di unità a livello universale. La questione che si pone è di concordare la modalità dell’esercizio di tale ministero, definito da Giovanni Paolo II come un “servizio di amore”.
Nei due millenni di storia della Chiesa come è cambiato il modo di esercitare il primato? E quale sviluppo potrebbe esserci per rendere questo esercizio accettabile anche alle altre Chiese che oggi non sono in piena comunione con Roma?
Senz’altro la modalità di esercizio del ministero petrino si è evoluta nel tempo, a seconda delle circostanze storiche e delle nuove sfide. Tuttavia, per molti dialoghi teologici i principi e i modelli di comunione onorati nel primo millennio rimangono paradigmatici per una futura restaurazione della piena comunione. Alcuni criteri del primo millennio sono stati individuati come punti di riferimento e fonti di ispirazione per l’esercizio di un ministero di unità riconosciuto a livello universale. Sebbene il primo millennio sia decisivo, molti dialoghi riconoscono che non dovrebbe essere idealizzato né semplicemente ricreato, poiché gli sviluppi del secondo millennio non possono essere ignorati e anche perché un primato a livello universale dovrebbe rispondere alle sfide contemporanee. In ogni caso, un rinnovato esercizio del primato deve in definitiva essere modellato sul servizio, sulla diakonia. Autorità e servizio sono strettamente correlati.
È possibile ipotizzare per il futuro una forma condivisa di esercizio del primato petrino su tutta la cristianità che sia separato dalla giurisdizione del Papa sulla Chiesa latina?
In effetti alcuni dialoghi ecumenici suggeriscono una più chiara distinzione tra le diverse responsabilità del Vescovo di Roma, in particolare tra quello che potrebbe essere definito il ministero patriarcale del Papa all'interno della Chiesa occidentale o latina, e il suo servizio primaziale di unità nella comunione di tutte le Chiese, sia d’Occidente che d’Oriente. Inoltre, rilevano la necessità di distinguere il ruolo patriarcale e primaziale del Vescovo di Roma dalla sua funzione di capo di Stato. L’accento sull’esercizio del ministero del Papa nella sua Chiesa particolare, la diocesi di Roma, che Papa Francesco ha particolarmente sottolineato, contribuisce a evidenziare il suo ministero episcopale che condivide con i suoi fratelli vescovi.
Questo documento viene pubblicato mentre la Chiesa cattolica sta vivendo un cammino sinodale incentrato proprio sul tema della sinodalità. Quale connessione esiste tra sinodalità e primato?
La maggior parte delle risposte e dei documenti di dialogo concordano chiaramente sulla reciproca interdipendenza tra primato e sinodalità a ogni livello della Chiesa: locale, regionale, e anche a livello universale. Di conseguenza il primato deve essere esercitato in un modo sinodale, e la sinodalità richiede il primato. Su tutti questi aspetti il nostro Dicastero ha anche organizzato dei convegni intitolati Listening to the East e Listening to the West, mettendoci all’ascolto delle diverse tradizioni cristiane in merito alla sinodalità e al primato, come contributo al processo sinodale.
Un passaggio decisivo riguardo al primato è stata la dogmatizzazione dell’infallibilità del Vescovo di Roma quando parla ex cathedra e il suo potere giurisdizionale sulla Chiesa. Può dirci se, e come, sia possibile una nuova lettura e comprensione del Concilio Vaticano I alla luce del Vaticano II e dei passi compiuti nel cammino ecumenico?
Certamente, alcuni dialoghi si sono impegnati ad interpretare il Concilio Vaticano I alla luce del suo contesto storico, del suo obiettivo e della sua ricezione. Siccome le sue definizioni dogmatiche sono state profondamente condizionate dalle circostanze storiche, suggeriscono che la Chiesa cattolica cerchi nuove espressioni e vocaboli fedeli all’intenzione originale, integrandoli in un’ecclesiologia di comunione e adattandoli all’attuale contesto culturale ed ecumenico. Si parla perciò di una “ri-ricezione”, o addirittura “riformulazione”, degli insegnamenti del Vaticano I.
Quali saranno i prossimi passi per continuare la riflessione comune delle Chiese sul primato?
Questo studio si conclude con una breve proposta dell’Assemblea plenaria del Dicastero, intitolata “Verso un esercizio del Primato nel XXI secolo”, che individua i suggerimenti più significativi proposti dalle varie risposte e dai dialoghi per un rinnovato esercizio del ministero dell’unità del Vescovo di Roma. Il nostro dicastero vorrebbe condividere questa proposta, assieme al documento di studio, con le diverse comunioni cristiani, chiedendo le loro riflessioni in merito. Ci auguriamo così di continuare la discussione “evidentemente insieme”, per un esercizio del ministero dell’unità del Vescovo di Roma “riconosciuto dagli uni e dagli altri”.
Vatican News