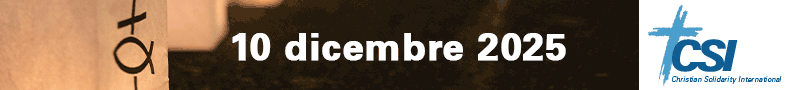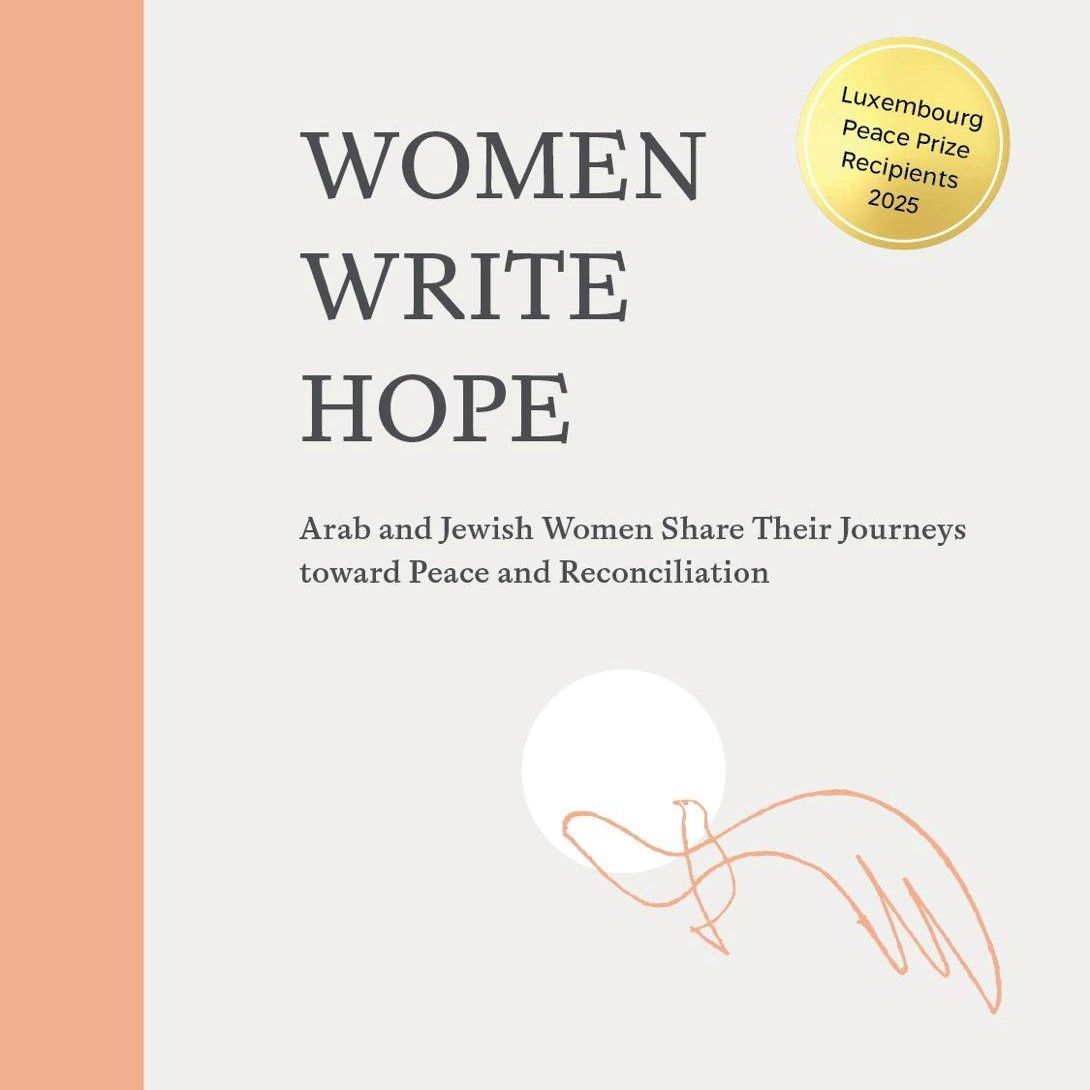Suor Nathalie Becquart, sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi, intervistata da cath.ch, fa una panoramica del processo sinodale, in corso da ottobre 2021 a livello della Chiesa universale. Sottolinea l'attuazione di questo processo sinodale a tutti i livelli della vita della Chiesa, in particolare incoraggiando tutti a parlare e ad ascoltare i più poveri.
Come si armonizza questo processo sinodale in diverse città e continenti? È possibile parlare di un inizio globale e omogeneo a livello mondiale?
Il processo è iniziato ovunque. C'è davvero un cammino comune, la sensazione che tutta la Chiesa, tutte le diocesi, stiano davvero percorrendo questo cammino sinodale. Allo stesso tempo, e questo è normale, ci sono ritmi diversi.
Ciò che mi tocca è la creatività, il modo in cui il processo viene adattato e implementato a livello locale. Questa era la linea prevista fin dall'inizio, invitare i partecipanti ad adattare le proposte del documento preparatorio alle realtà locali. L'idea è che questo sinodo globale risuoni nella missione di ogni diocesi.
Le situazioni sono estremamente varie. Per esempio, l'America Latina, da dove viene il Papa, ha vissuto la ricezione del Vaticano II con l'assemblea ecclesiale latinoamericana, e quindi ha una forte esperienza dello stile sinodale. Da parte sua, la Francia è senza dubbio il Paese del mondo che ha tenuto il maggior numero di sinodi diocesani dal Vaticano II. Ha quindi un vero e proprio terreno sinodale con laici impegnati.
Ciò che mi tocca è la creatività, il modo in cui il processo è adattato, implementato localmente
In altri Paesi, come il Laos, la piccola Chiesa locale non ha mai avuto un Sinodo e nemmeno sentito parlare di sinodalità. Hanno tutto da imparare ma sono aperti. Quindi ci sono grandi differenze, ma ognuno può saltare sul carro dove si trova.
Alcuni sacerdoti esprimono la loro ansia e fatica in relazione a questo processo. Come possiamo affrontare il disorientamento di una parte del clero?
Ci sono diverse ragioni per l'ansia di alcuni sacerdoti. Prima di tutto, naturalmente, alcuni vedono il Sinodo come una "cosa in più", in cima a un pesante carico di lavoro e ad altre priorità locali. E poi c'è il fatto di esercitare il ministero in modo nuovo, in questo stile sinodale che implica la corresponsabilità. Non sempre sono attrezzati e formati per attuare questo nuovo stile. La sfida del Sinodo è quindi quella di creare un dialogo più forte tra sacerdoti e laici, e il Papa continua a incoraggiarlo.
Finché non hanno vissuto in prima persona il processo sinodale e i suoi frutti, a volte hanno difficoltà a capirlo. Alcuni vescovi cercano quindi di coinvolgere i loro sacerdoti riunendoli attorno al metodo sinodale. Per esempio, il cardinale Piat delle isole Mauritius mi ha detto che i sacerdoti della sua diocesi che erano riluttanti al processo sono stati "spiazzati" quando ha organizzato una riunione di tutto il presbiterio intorno al metodo sinodale. Sono poi partiti con entusiasmo per proporlo nelle loro parrocchie.
I sacerdoti e alcuni vescovi devono essere aiutati a capire che il processo sinodale non toglierà il loro ruolo, ma li condurrà a un nuovo modo di esercitare la loro autorità. In una Chiesa sinodale, nessuno prende decisioni da solo. Questo non toglie la responsabilità della persona che prende una decisione finale, ma fare un processo di consultazione e discernimento con gli interessati non è lo stesso che prendere una decisione seguendo solo le proprie idee.
Si trova di fronte a qualche riluttanza tra i vescovi stessi?
Le cose stanno accadendo per azione capillare nelle conferenze episcopali. In alcuni casi, l'approccio sinodale si diffonde facilmente. In altri Paesi, c'è meno collegialità e dipende da ogni vescovo. Quindi varia. Naturalmente, quando il vescovo è entusiasta, si diffonde più facilmente nella sua diocesi.
I casi di vera opposizione sono rari. Quello che stiamo vivendo è un frutto e un dispiegamento del Vaticano II. Si possono fare delle critiche, ma quando un vescovo si oppone di petto al Sinodo, questo esprime un'opposizione al Concilio Vaticano II in quanto tale.
Quello che stiamo vivendo è un frutto e uno svolgimento del Vaticano II
Come si può rendere la sinodalità attraente e interessante al di là del nucleo di cattolici convinti?
Piuttosto che parlare solo di sinodalità, abbiamo bisogno di sperimentarla. Quello che stiamo cercando di fare, nel nostro modo di animare il processo, di dialogare con le Chiese locali, è di incoraggiare le esperienze. Questa è la posta in gioco: che nelle parrocchie, nei gruppi, si possa proporre un'esperienza di ascolto reciproco e dello Spirito Santo, radicata nella preghiera.
La sinodalità si scopre veramente solo vivendola. L'espressione "Sinodo sulla sinodalità" non parla a molti, ma "comunione, partecipazione, missione", tutti capiscono.
Questo processo globale si sovrappone ai cammini sinodali vissuti a livello nazionale, con orientamenti diversi. Il cammino sinodale tedesco ha proposto opzioni radicali, come l'ordinazione delle donne… Come possiamo conciliare la preoccupazione per l'unità della Chiesa con queste opzioni "democratiche"?
Quello che scopriamo con Papa Francesco è una logica di unità con l'immagine del poliedro, che per lui simboleggia l'unità e la diversità. Fin dall'inizio, la Chiesa ha avuto un principio di unità che si sviluppa nelle diverse culture. Dal Vaticano II, c'è stata una maggiore consapevolezza dell'inculturazione, cioè della diversità delle società, delle culture, del modo di essere Chiesa, pur mantenendo il primato e l'unità.
È chiaro, per esempio, che il modo di vivere la liturgia in Africa non è lo stesso che in Europa. All'interno della Chiesa cattolica c'è una diversità di riti, con le Chiese orientali, il rito zairiano… Allora fino a che punto si può arrivare nella diversità, e quali sono i fondamenti necessari per la comunione? Cosa può essere inculturato? Siamo ancora in viaggio.
Possiamo vedere che con il Sinodo sull'Amazzonia abbiamo esplorato soluzioni per una regione specifica, con problemi che non sono gli stessi di altri Paesi. Così le Chiese locali affrontano questo processo secondo la loro esperienza.
Quali strumenti di formazione vengono proposti per evitare che il Sinodo diventi un "dibattito parlamentare"?
Infatti, il Papa continua a martellarlo: il Sinodo non è un dibattito parlamentare con una logica di maggioranza e minoranza, ma un processo spirituale. Così abbiamo proposto un metodo ispirato al principio della "conversazione spirituale". Non è una discussione a tutto tondo, ma tutto deve iniziare con un tempo di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, e poi ogni persona viene ascoltata.
Questo metodo è stato sperimentato all'apertura del Sinodo il 9 ottobre 2021. C'è stata una sessione plenaria di due ore, seguita da due ore in piccoli gruppi che includevano cardinali, giovani e delegati di diversi paesi. Per due ore hanno sperimentato questa metodologia di ascolto sinodale.
Il Papa continua a martellare: il Sinodo non è un dibattito parlamentare con una logica di maggioranza e minoranza
Questo viene ora implementato sul campo. E noi, con la commissione spirituale, stiamo mettendo a disposizione dei gruppi vari strumenti. Nei miei vari interventi, soprattutto negli incontri con le conferenze episcopali e i referenti sinodali delle comunità e dei movimenti, sia online che di persona, cerchiamo sempre di attuare questo stile sinodale, con tempi di preghiera e di silenzio. Dopo aver ascoltato otto o dieci persone, c'è un tempo di silenzio. Questo aiuta a svolgere questo processo sinodale.
Come possiamo incoraggiare la partecipazione dei giovani e delle persone lontane dalla Chiesa?
Questa è infatti una forte enfasi espressa nel documento preparatorio e nella guida pratica, così come in tutte le nostre riunioni. Stiamo cercando di mobilitare tutte le reti, per esempio incoraggiando le conferenze episcopali e le diocesi a lavorare con la Caritas, la pastorale dei migranti, le cappellanie delle prigioni e degli ospedali, o anche l'educazione cattolica, che raggiunge i giovani che sono abbastanza lontani dalla Chiesa.
A livello internazionale, lo stiamo anche attuando lavorando in particolare con la Caritas, la piattaforma Laudato Si' e la rete delle università cattoliche. Dobbiamo costruire su tutto ciò che già esiste.
Recentemente è stata organizzata una giornata al Centre Sèvres di Parigi sul tema "Ascoltare la voce dei più poveri nel processo sinodale", con un gruppo di teologi che lavorano da dieci anni con le reti ATD e le diaconie. Hanno prodotto un ottimo strumento che abbiamo distribuito nella nostra newsletter e tradotto in diverse lingue. Penso anche a una diocesi spagnola che ha sviluppato un gioco per coinvolgere i bambini nel processo sinodale.
Di recente ho partecipato a un webinar con la Sezione Migranti e Rifugiati su come coinvolgere migranti, sfollati e rifugiati nel processo. Vescovi e leader della Pastorale dei Migranti e del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS) hanno presentato le loro esperienze. Penso, per esempio, al lavoro svolto in un campo di rifugiati in Kenya per proporre loro l'approccio sinodale.
Dobbiamo quindi identificare ciò che viene fatto e incoraggiare la messa in rete. Ci sono buone pratiche, buone idee, buone esperienze sul campo.
La sfida del Sinodo è anche quella di disinnescare il rischio di abusi, semplicemente facendo in modo che le persone si ascoltino e parlino tra loro?
Mi sembra chiaro che la visione della Chiesa sinodale ci porterà lontano dalla visione della Chiesa clericale, che ha permesso che si verificassero degli abusi. L'approccio sinodale, che permette a tutti di essere ascoltati, di contribuire con la propria voce, di trovare modi per camminare insieme, dovrebbe permetterci di uscire da possibili derive autoritarie, e in ogni caso di identificarle.
È una strada lunga, ma fruttuosa, che deve iniziare con l'ascolto. Perché quello che è successo in tutte queste forme di abuso è che non c'è stato questo ascolto.
Mi è chiaro che la visione della Chiesa sinodale ci porterà fuori dalla visione della Chiesa clericale.
Lei stessa è una religiosa ignaziana. Come può la vita religiosa portare strumenti specifici a questo processo sinodale?
La vita religiosa è intrinsecamente comunitaria, quindi ha una dimensione sinodale. La sua tradizione di governo con capitoli significa che ha esperienza di sinodalità e discernimento. Può quindi svolgere un ruolo di primo piano nell'aiutare la Chiesa a reimparare la sinodalità.
Allo stesso tempo, e lo ripeto spesso quando incontro i superiori, nessuna comunità ha finito la sua "conversione sinodale". Devono quindi vivere questo viaggio anche per se stessi.
Ma hanno un'esperienza utile, e in molti casi, i religiosi e le religiose sono coordinatori o fanno parte delle equipe sinodali istituite dalle conferenze episcopali e dalle diocesi. I religiosi e le religiose hanno quindi un ruolo di primo piano.
(cath.ch/imedia/cv/bh/ traduzione catt.ch)