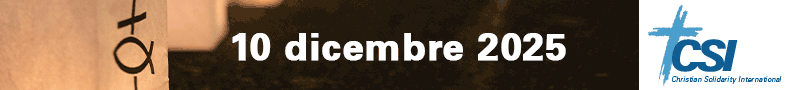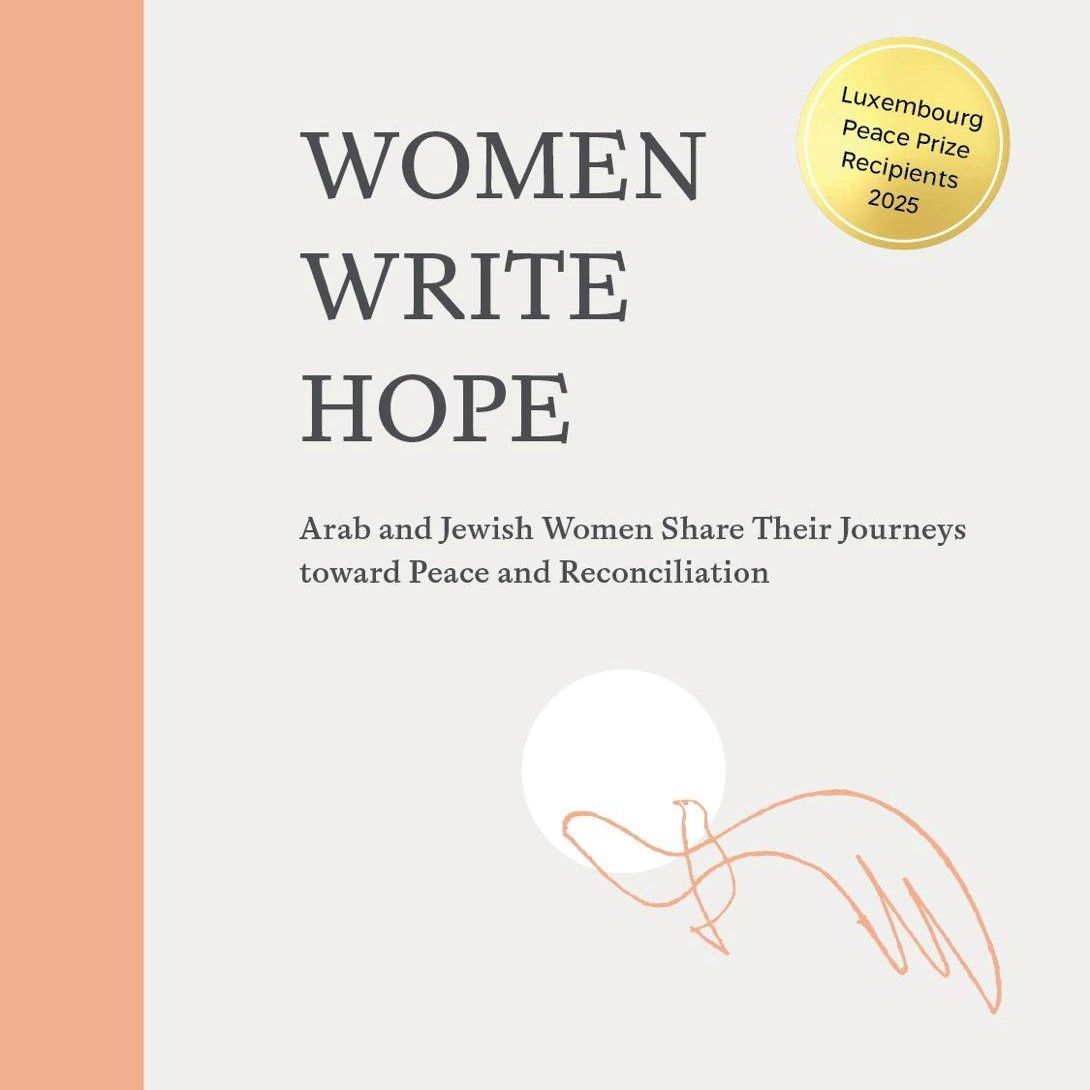Nei giorni scorsi una «Dichiarazione della Santa Sede» del 21 luglio è intervenuta merito del Cammino sinodale tedesco – «Non sarebbe lecito avviare nelle diocesi, prima di un’intesa concordata a livello di Chiesa universale, nuove strutture ufficiali o dottrine, che rappresenterebbero una ferita alla comunione ecclesiale e una minaccia all’unità della Chiesa». Parole ferme a cui i diretti interessati hanno risposto dicendo che non era nelle loro intenzioni attuare nulla che prima non fosse stato deciso a livello di Chiesa Universale. Ad ogni modo, la vicenda, hanno osservato in molti, mette a tema la questione del rapporto tra Chiese locali e Chiesa universale nel tempo della sinodalità. Massimo Faggioli, docente di teologia e scienza delle religioni alla Villanova University, negli Stati Uniti, voce autorevole per comprendere Sinodo, Concilio e attuale pontificato ha scritto per La Croix international un testo sul tema, affrontando la questione a partire dall'esperienza del sinodo australiano e del concilio plenario di quella Chiesa locale che si è da poco svolto. I colleghi del blog Il Regno ne hanno fatto una traduzione dalla quale estrapoliamo ampi stralci. Ecco l'articolo di Massimo Faggioli:
Il Concilio plenario australiano: lungamente preparato
Un modo per guardare il V Concilio plenario australiano (Sydney 3-9 luglio 2022) è quello di considerare ciò che può insegnare al «processo sinodale» lanciato da papa Francesco, e che culminerà con l’Assemblea dell’ottobre 2023 a Roma, ma che sicuramente continuerà anche dopo. Penso che ci siano sei importanti insegnamenti per le altre Chiese che stanno preparando le loro assemblee sinodali in tutto il mondo: preparazione; persone; procedura; polarizzazione; preghiera; processo post-plenario.
Il primo è la preparazione. Il V Concilio plenario ha richiesto molto tempo per essere preparato e celebrato. Ci vorrà tempo anche per recepirlo. Le prime idee su un Concilio plenario risalgono addirittura a prima dell’elezione di papa Francesco; uno dei proponenti era l’allora arcivescovo di Adelaide, Philip Wilson, più di dieci anni fa, quando la sinodalità non era esattamente qualcosa di popolare nell’establishment ecclesiastico e in Vaticano.
Le proposte di un Concilio plenario non solo sono sopravvissute, ma sono state rafforzate dalla tempesta della Royal Commission sullo scandalo degli abusi e delle violenze nella Chiesa. Ci è voluta molta energia da parte dell’allora presidente della Conferenza episcopale australiana, l’arcivescovo Mark Coleridge, per superare le resistenze e le opposizioni e annunciare il Concilio plenario nel 2018.
Dopo un lungo processo di preparazione nelle Chiese locali, la prima assemblea si è svolta dal 3 al 10 ottobre 2021. Anche i teologi sono stati una parte insostituibile del successo.
Il ruolo delle persone
Il secondo è quello delle persone. Il Concilio plenario australiano è stata un’esperienza di circa 300 delegati che hanno rappresentato l’intero popolo di Dio in un modo più pieno e ricco del concetto di rappresentanza politica. Come ha osservato il corrispondente di The Tablet, Christopher Lamb (che si è recato in Australia per la II assemblea), durante il processo sinodale è emersa un nuova leadership. Il fatto che il vescovo Tim Costelloe, presidente della Conferenza episcopale e presidente del Concilio, sia stato fuori gioco per la maggior parte della settimana probabilmente a causa del COVID non ha fermato il Concilio.
È stata l’abilità del vicepresidente Shane Mackinlay, vescovo di Sandhurst (Bendigo), a salvare il Concilio dall’evento dirompente di mercoledì 6 luglio, con la crisi sul voto sul ruolo delle donne nella Chiesa (vedi sotto).
Ma anche le persone in Assemblea. L’idea di dividerle in piccoli gruppi attorno a un tavolo è stata molto intelligente. L’attività di «conversazione spirituale», che ha preso buona parte della giornata, ha favorito una condivisione profonda e nel corso della settimana si è registrato un certo movimento nella comprensione dei singoli.
C’erano poi i periti o i consulenti teologici che hanno potuto sedersi dietro gli osservatori. Inoltre, i membri del Concilio anche con le loro voci critiche hanno mantenuto onesto il processo: i gruppi di cattolici preoccupati attivi sui social media, i blog quotidiani di cattolici di spicco, le voci riflessive dei mass media. Questa è stata una componente critica in senso positivo.
Il funzionamento della procedura
Terzo, la procedura. Come nel caso del novembre 1962 durante il dibattito sullo schema del Vaticano II sulla rivelazione divina, il Concilio plenario australiano ha avuto la sua crisi il 6 luglio per il voto deliberativo sulla «Parte 4: Testimoniare l’uguale dignità delle donne e degli uomini». I vescovi non erano riusciti ad approvare con la maggioranza dei due terzi richiesta, nessuna delle mozioni sull’uguaglianza delle donne e degli uomini nella Chiesa (nemmeno la dichiarazione introduttiva generale) e ciò è stato immensamente doloroso. La reazione in sala è stata immediata.
Circa 60 persone (per lo più donne, due vescovi, alcuni sacerdoti e laici) sono rimaste in piedi in fondo alla sala. Il vescovo Mackinlay ha annunciato che ci sarebbe stato un cambio di programma, con un’ulteriore discussione sulla Parte 4, e che i vescovi si sarebbero incontrati con il Comitato direttivo durante il pranzo per discutere su come procedere. La Parte 4 del documento è stata poi rivista da un nuovo gruppo di redazione con una piccola revisione, senza usare il linguaggio della «complementarietà», è stata poi ripresentata e ha ottenuto un sostegno molto forte. Va dato merito alla buona volontà di molti vescovi di aver voluto trovare una via d’uscita.
E anche se c’era una precisa strategia pianificata fin dall’inizio da un gruppo per bloccare tutte le mozioni creative, questa non ha funzionato. Come nel Vaticano II, la strategia di dire «no» a tutto ciò che mette in discussione lo status quo non funziona in assemblee ecclesiali ben preparate e ben guidate. La procedura ha funzionato ed è stata in grado di superare la crisi.
Tuttavia, è necessario riflettere teologicamente e canonicamente sulle distinzioni tra ciò che è consultivo o deliberativo e i processi decisionali delle assemblee e il loro grado di vincolo per le Chiese. Si tratta di un aspetto molto importante per la Commissione teologica del Sinodo dei vescovi dell’ottobre 2023, che avrà una riunione molto importante a Roma nel settembre 2022. La ricerca di un modo per superare l’impasse dopo il voto deliberativo negativo dei vescovi sulle donne ha dimostrato che, dopo il voto deliberativo, è necessario un ulteriore passo d’accoglienza da parte dell’intera assemblea. In una Chiesa sinodale, consultazione e deliberazione devono essere intese come una relazione circolare.
La sconfitta della polarizzazione
Quarto: la polarizzazione. La vera sfida della sinodalità è superare e non alimentare la polarizzazione ecclesiale causata da piccole minoranze conservatrici. È noto, ad esempio, il modo in cui il card. George Pell, l’uomo di Chiesa più influente in Australia dopo il concilio Vaticano II, ha parlato del Concilio plenario nell’ultimo decennio. Reagire con una posizione che definirei ingenuamente «di sinistra» non fa altro che alimentare la polarizzazione e la divisione della Chiesa e ostacolare un movimento positivo, che il Concilio plenario ha invece portato avanti in modo significativo.
La sinodalità è la via per sconfiggere la polarizzazione nella Chiesa: non solo perché mostra, in un ambiente fisico e liturgico, la reale dimensione e l’importanza di minoranze minuscole ma rumorose, ma anche perché aiuta a riflettere in modo ecclesiale e non di mera reazione sulle questioni che queste minoranze rumorose sollevano.
Quinto: la preghiera. Già nei primi giorni di preparazione, il Comitato esecutivo dei vescovi lo aveva sottolineato. Ed è stata costantemente sollecitata. La struttura delle giornate dell’Assemblea prevedeva un tempo di preghiera e sui vari temi c’erano «conversazioni spirituali» in cui le persone condividevano ciò che lo Spirito diceva loro. Un’atmosfera di preghiera esclude ogni farneticazione. Il dialogo sinodale non deve essere come un dibattito parlamentare dove chi vince prende tutto.
Le decisioni finali e la loro recezione
Sesto e ultimo punto: i risultati e il processo post-assembleare. Alcuni hanno detto che i risultati sono blandi, ma io non la vedo così: la richiesta di ritorno del terza forma del Rito della confessione; la richiesta di revisione della traduzione inglese del Messale del 2010; l’affermazione dell’uguaglianza delle donne e la richiesta della loro nomina negli organi direttivi.
Il Concilio plenario fa parte del movimento sinodale, che è «il contenitore» che sta portando avanti la Chiesa. Forse, guardando all’Australia, la Chiesa ha visto in questo caso i limiti della struttura del Concilio plenario, ostacolata da un approccio giuridico che potrebbe non servire al meglio il discernimento comunitario. L’uso di Francesco dei sinodi (a livello locale, nazionale e universale) sembra un’opzione migliore. Ma non potrà ignorare quanto accaduto in Australia (e in Germania).
Il processo di recezione di questo evento ecclesiale non sarà dunque meno importante delle sue decisioni finali. Il V Concilio plenario australiano è stato un evento storico che dovrà essere studiato come tale. Dopo l’8 dicembre 1965, molti vescovi e consulenti teologici chiave del Concilio dissero che il Vaticano II era solo l’inizio di un inizio (per esempio, Karl Rahner), e che il Vaticano II stava solo per iniziare (Bernard Häring). Questo vale anche per ciò che è accaduto in Australia negli ultimi anni e che è culminato nell’Assemblea di Sydney del luglio 2022. Il V Concilio plenario è finito, ma in un certo senso inizia ora.
Massimo Faggioli