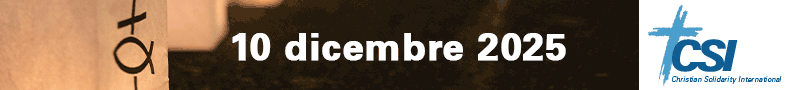di Katia Guerra
«La Buona Novella», composta e cantata da Fabrizio De André (1940-1999) viene portata in scena dall’attore italiano Neri Marcorè, diretto da Giorgio Gallione, la prossima settimana anche in Ticino: al Centro Culturale di Chiasso e al Teatro sociale di Bellinzona . Siamo davanti ad una sorta di sacra rappresentazione contemporanea nella quale si alternano le canzoni di De André con i brani narrativi a cui l’autore si è ispirato e che provengono da alcuni Vangeli apocrifi. Ne emerge un cristianesimo dai tratti umani e dagli aspetti legati alla sensibilità degli anni Sessanta per i diseredati e gli oppressi. Lo spettacolo, tuttavia, si mostra libero nella riproposizione dei testi di De André. Ne parliamo con un teologo che interverrà il 18 febbraio a Bellinzona, in una serata di approfondimento, preludio allo spettacolo dei giorni successivi: Vittorio Secco, assistente di Storia del cristianesimo alla Facoltà Valdese di Roma.
Dott. Secco, cosa sono i Vangeli apocrifi dai quali prende spunto De André e quale è la loro genesi?
Partiamo innanzitutto da che cosa significa apocrifo. Nella tradizione, ciò che è apocrifo viene normalmente contrapposto a ciò che è canonico. Potremmo dire che è apocrifo tutto ciò che non è entrato nel canone della Bibbia ma che presenta situazioni o personaggi legati alla Bibbia. I Vangeli apocrifi hanno avuto in realtà una genesi molto simile a quelli inseriti nel Nuovo Testamento, anche se in tempi più tardivi. Essi non sono tanto importanti per ricostruire la figura del Gesù storico, quanto piuttosto la sua ricezione tra i cristiani dei primi secoli. Oggi questi testi sono studiati soprattutto per comprendere meglio i diversi tipi di cristianesimo sorti dal II secolo e fino al IV secolo, periodo in cui poi avviene una maggiore «standardizzazione» della fede cristiana.
Da quali Vangeli apocrifi il cantautore si è lasciato ispirare?
Direi da due opere in particolare: una che viene chiamata Protovangelo di Giacomo, e poi dal Vangelo arabo dell’infanzia, un testo conservato in lingua araba solamente in due manoscritti. Stiamo parlando nel primo caso di un’opera del II secolo dopo Cristo, mentre il secondo testo è stato verosimilmente scritto tra il IV e il V secolo. Il primo si concentra sull’infanzia di Maria e sulle vicende che portano alla nascita di Gesù. Nel secondo si sviluppano invece i temi legati all’infanzia di Gesù, quindi dalla nascita, alla fuga in Egitto fino alla fine del capitolo due di Luca (ndr. Gesù tra i maestri del tempio). Si tratta di narrazioni spesso molto aneddotiche, dai tratti miracolistici.
Come ha utilizzato il cantautore italiano queste storie antiche?
L’uso che Fabrizio De André fa di questi Vangeli in realtà restituisce delle immagini di Gesù e delle persone del suo nucleo familiare, Maria, Giuseppe e anche altri personaggi, molto diverse da quelle presenti negli stessi testi. In essi Gesù sin dall’inizio è molto consapevole della propria divinità. È sì un bambino, che però parla come un adulto, fa cose meravigliose e straordinarie: in questo senso siamo lontani dai tratti fortemente umanizzanti che De André invece attribuisce a Cristo, che pure è sempre una figura sullo sfondo nel suo album. Nella sua «Buona Novella», di fatto Cristo non parla. La Maria descritta nel Protovangelo di Giacomo è fondamentalmente un oggetto sacro, un tabernacolo di cui occorre preservare la purezza in vista della nascita di Cristo, e per questo deve passare la propria infanzia nel Tempio ed essere data in sposa all’anziano Giuseppe. De André riprende questa tradizione, ma Maria diventa una bambina strappata alla sua infanzia e «gestita» dai sacerdoti del Tempio, per essere poi data in sposa a Giuseppe e diventare madre. De André recupera dunque l’umanità profonda di Maria, come bambina, adolescente, madre. Il cantautore si rifà indubbiamente ad episodi raccontati da questi Vangeli, ma li adatta completamente ad una sensibilità che è quella degli anni Sessanta nel Novecento: intende esprimere in primo luogo empatia per coloro che non hanno voce, per i più deboli, gli oppressi, i diseredati. Maria, il ladrone Tito, ad esempio, ma lo stesso Gesù, diventano figure simbolicamente rappresentative di queste categorie. In conclusione, Fabrizio De André ha sì recuperato queste storie antiche, ma ne ha fatto una narrazione nuova. Per cui non sarebbe sbagliato dire che il cantautore genovese ha effettivamente composto il suo proprio vangelo apocrifo.
Lo spettacolo a Chiasso e Bellinzona
«La Buona Novella», da Fabrizio De Andrè, in versione musico-teatrale, con la regia di Giorgio Gallione e interpretata da Neri Marcorè e Rosanna Naddeo, verrà messa in scena martedì 18 febbraio alle ore 20.30 al Centro Culturale di Chiasso, e mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio al Teatro sociale di Bellinzona (inizio alle ore 20.45).
Per entrare nel mondo dei Vangeli apocrifi, ai quali si è ispirato Fabrizio De André, è previsto martedì 18 febbraio alle 20.45 al Teatro sociale di Bellinzona un incontro di approfondimento con il biblista Ernesto Borghi, presidente dell’ABSI e Vittorio Secco, assistente di Storia del cristianesimo, Facoltà Valdese di Roma.