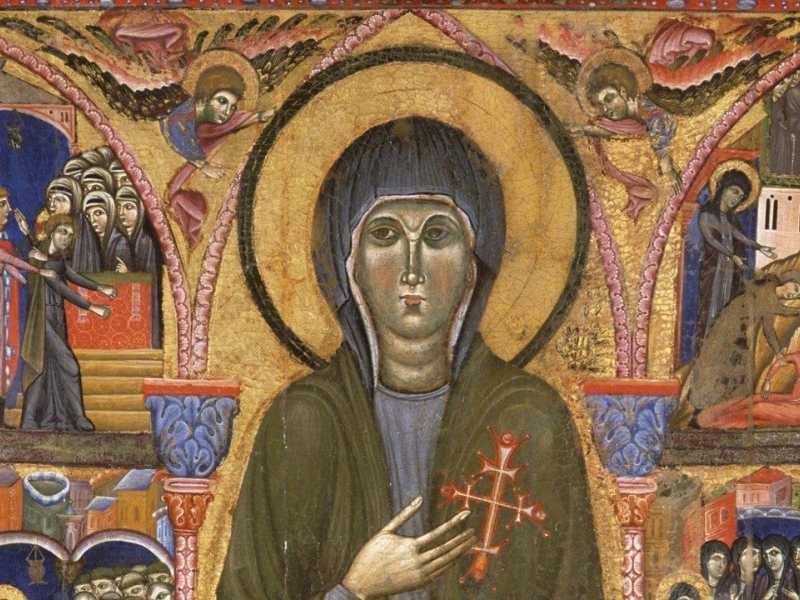L’8 maggio, nel suo primo discorso, papa Leone XIV ha dichiarato: «Sono un figlio di Sant’Agostino – agostiniano – che ha detto: “con voi sono cristiano e per voi vescovo”». Agostino (354-430), Santo e Dottore della Chiesa, uomo di passione e di solida fede, di intelligenza fine e grande premura pastorale, ha lasciato un’impronta profondissima nella vita culturale dell’Occidente e di tutto il mondo. Come sottolineava Benedetto XVI, «di rado una civiltà ha trovato uno spirito così grande, che sapesse accoglierne i valori ed esaltarne l’intrinseca ricchezza, inventando idee e forme di cui si sarebbero nutriti i posteri».
Del pensiero di Agostino dialoga con Catholica e catt.ch la professoressa Paola Müller, docente di Storia della filosofia medievale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Quale ritiene sia l’eredità maggiore che ci ha lasciato Agostino?
«Credo che l’eredità più vitale di Agostino consista nell’aver risvegliato, con straordinaria lucidità, il valore della vita interiore. In un mondo sempre più assordato da stimoli esterni e scollato da sé, la sua voce ci invita a ritrovare il silenzio necessario per ascoltare ciò che abita nel cuore. L’interiorità, per Agostino, è il luogo della verità e della libertà autentica: il movimento non è quello di una chiusura solitaria, ma di un ascolto autentico, di un cammino in cui l’uomo, sostenuto dalla grazia, riconosce la propria vulnerabilità e si apre all’Assoluto. In questo senso, “rientrare in se stessi” non è ripiegarsi, ma riconquistare una profondità che rende possibile un nuovo modo di stare nel mondo: non per evadere dalla realtà, ma per illuminarla con uno sguardo trasformato. Questa interiorità dunque non è chiusura, ma comunione. Chi la scopre e la coltiva non si sottrae al mondo, ma lo trasfigura, irradiando la luce che ha trovato in sé».
Vi è un aspetto del pensiero di Agostino che sarebbe particolarmente utile riscoprire in Occidente, in società che sono – per la prima volta nella storia – istituzionalmente non religiose?
«Sì, oggi più che mai è prezioso riscoprire in Agostino la centralità della coscienza come luogo in cui la persona si interroga, ascolta e si orienta. In un’epoca in cui le società occidentali sono sempre più istituzionalmente secolarizzate, Agostino ci ricorda che la ricerca del senso è un’esigenza inscritta nella coscienza umana. In questo modo il pensiero agostiniano parla con forza anche a chi non crede: la ricerca della verità, infatti, nasce dal cuore dell’uomo, prima ancora che da una fede o da una dottrina. Il suo invito a ritornare dentro di sé – “in interiore homine habitat veritas” – assume così una valenza antropologica e culturale universale. Agostino ci ricorda che ogni essere umano porta in sé una domanda che non può essere cancellata, e che solo tornando a quella fonte interiore possiamo ritrovare orientamento, senso, responsabilità. È un pensiero che restituisce dignità alla persona, alla sua libertà e alla sua sete di infinito».
La speranza, per Agostino, nasce da una visione profonda dell’uomo: può illustrare in che termini essa è il cuore stesso della sua antropologia?
«Per Agostino, la speranza non è un semplice sentimento consolatorio, ma il cuore pulsante della sua visione dell’uomo. L’essere umano, creatura inquieta e desiderante, non si accontenta mai del presente: è strutturalmente orientato verso un bene più grande, verso ciò che ancora non possiede ma già attende. La speranza nasce da questa tensione profonda, da una verità incisa nell’anima: “Ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te”. Non è fuga dalla realtà, ma fiducia operosa in un compimento che dà senso al cammino. È attesa che plasma, che educa il cuore, che sostiene nei giorni oscuri. In Agostino, sperare significa vivere nella consapevolezza di una promessa che verrà mantenuta. Per questo, la speranza è anche responsabilità: ci chiede di custodire il tempo, di non disperderci, e di credere – nonostante tutto – che l’uomo non è mai solo nel suo pellegrinaggio».
Quali aspetti del pensiero di Agostino possono in particolare accompagnare e sostenere il ministero petrino?
«Nel pensiero di Agostino vi sono numerose dimensioni che parlano in modo profondo al ministero petrino, a cominciare dall’amore per l’unità. Papa Leone XIV lo ha ricordato nell’omelia d’inizio pontificato: “Amore e unità: queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù”. Agostino, che fu pastore, teologo e monaco, ha fondato tutta la sua vita e la sua opera sul desiderio di ricondurre ogni frammentazione all’unità, sia nell’interiorità dell’uomo sia nella comunione sociale ed ecclesiale. La Regola agostiniana ne è un esempio eloquente: “Abbiate un sol cuore e un’anima sola protesi verso Dio”. Il monastero non è, per Agostino, un rifugio separato, ma un laboratorio di comunione, segno del più ampio disegno di Dio: radunare in Cristo i figli dispersi. In questa prospettiva, il ministero petrino è chiamato a custodire e promuovere un’unità che non è uniformità, ma armonia generata da un amore purificato e paziente, capace di edificare ponti nel cuore della Chiesa e del mondo».