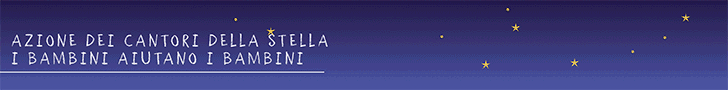Fratelli tutti. La lettera enciclica di papa Francesco si inserisce in una grande tradizione che parte dalle parole di Gesù, dai vangeli, da San Francesco, fino a Carlo de Foucauld, «il piccolo fratello universale» e a Carlo M. Martini («farsi prossimo»). Cambiano i contesti sociali e culturali, ma per la Chiesa e i per credenti la chiave d’interpretazione è sempre quella: l’amore di un Dio che è Padre di tutti (sì, anche se qualche critico del Papa vorrebbe restringere l’uso del termine fratelli ai soli cristiani!) e che ama tutti come figli, e chiede a tutti di riconoscersi fratelli, proprio perché tutti, anche quelli che non lo conoscono sono da Lui, che ama ogni creatura, amati. Francesco adopera un metodo di discernimento chiaro: descrive la situazione del mondo oggi (capitolo 1: le ombre di un mondo chiuso), per leggerla alla luce del Vangelo (capitolo 2: un estraneo sulla strada), e giungere a delle proposte perché nella fraternità si cammini verso la costruzione di un mondo migliore, rinnovato. La parola di Gesù che deve illuminare il processo di discernimento, è la parabola del Samaritano. La presentazione della situazione e la descrizione dei personaggi è molto efficace. «Il racconto, (…) ci rivela una caratteristica essenziale dell’essere umano (…): siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”. Questo ci deve indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana» (68). La lettura del commento di Francesco è fondamentale, e il capitolo secondo va letto e meditato con grande attenzione, proprio per non ridurre l’enciclica a un discorso sociale o politico. La parabola del Vangelo è la chiave necessaria per capire il discorso di Francesco, che la presenta come “una storia che si ripete”. La descrizione dei personaggi è vivace e deve colpire il lettore. «In quelli che passano a distanza c’è un particolare che non possiamo ignorare: erano persone religiose. Di più, si dedicavano a dare culto a Dio…Questo è degno di speciale nota: indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace» (74). Francesco ricorda una frase di San Giovanni Crisostomo: «Volete onorare veramente il corpo di Cristo? Non disprezzatelo quando è nudo. Non onoratelo nel tempio con paramenti di seta, mentre fuori lo lasciate a patire il freddo e la nudità». Aggiunge Francesco: «Il paradosso è che, coloro che dicono di non credere possono vivere la volontà di Dio meglio dei credenti». Nel racconto di Gesù, il paradosso è presentato dalla figura del samaritano: uno straniero, partecipe di una tradizione religiosa non riconosciuta, anzi in parte disprezzata, da Israele. Così, nella lettera di papa Francesco, lo straniero diventa la figura centrale: il modello da imitare e il fratello da accogliere sempre. A pagina 3 di «Catholica» altri commenti sull’Enciclica.
Azzolino Chiappini, pro-rettore emerito della Facoltà di Teologia di Lugano