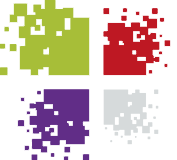di Chiara Gerosa
C’è un potere che nasce dal ventre. Non urla, non impone. Custodisce, genera, ascolta. È il potere delle madri. Di quelle che hanno perso un figlio e che ogni giorno scelgono di non perdere anche la speranza. In Terra Santa, tra le ombre della guerra, ci sono donne che decidono di guardarsi negli occhi anziché puntarsi contro il dito. Donne palestinesi e israeliane che si abbracciano nel silenzio di chi conosce la stessa ferita. La loro storia è stata raccontata allo scorso Meeting di Rimini.
Layla al-Sheik è una madre palestinese di Battir, villaggio vicino a Betlemme. Ventidue anni fa suo figlio Kusai morì tra le sue braccia, a soli sei mesi, mentre tentava di raggiungere un ospedale: il viaggio si fermò a un checkpoint israeliano, quattro ore di attesa che furono fatali. Per anni Layla non parlò della tragedia neppure agli altri figli, temendo che la rabbia li spingesse alla vendetta. Poi, sedici anni dopo, scoprì il Parent Circle, un forum che riunisce famiglie israeliane e palestinesi colpite dal conflitto. Lì, per la prima volta, guardò un israeliano come un essere umano. «Erano le stesse lacrime, la stessa sofferenza», racconta. Da allora porta il suo messaggio di riconciliazione in Palestina e nel mondo.
Anche Elana Kaminka conosce quelle lacrime. Madre di quattro figli, ha perso il maggiore, Yanai, ufficiale dell’esercito israeliano, ucciso il 7 ottobre 2023 a soli 21 anni dopo aver salvato decine di compagni e civili. Pochi mesi dopo, mentre il Paese è ancora paralizzato dallo shock, scrive su un quotidiano: «La violenza non porterà del bene a nessuno». Un atto di coraggio che ancora oggi ripete, ispirandosi ai valori che Yanai aveva lasciato scritti: amore, responsabilità, servizio. «Tutto ciò che faccio, lo faccio al posto suo – dice – perché lui avrebbe dato tanto al mondo. Non posso cambiare ciò che è accaduto, ma posso scegliere come reagire». Elana e Layla si sono incontrate proprio al Parent Circle. Sedute vicinissime davanti a me, raccontano le loro storie con una benevolenza reciproca che mi commuove profondamente. Vedo come si guardano, come si tengono le mani. Un segno fortissimo di speranza. Non cancellano il dolore, ma lo trasformano in testimonianza viva: «Anche un solo figlio perso, israeliano o palestinese, è troppo», dice Elana. «E allora perché dare la colpa all’altro? Non è Layla ad aver ucciso mio figlio, come non sono io responsabile della morte del suo». Accanto a loro c’è suor Azezet Habtezghi Kidane, comboniana eritrea conosciuta come suor Aziza. Ha vissuto quattordici anni in Terra Santa, dopo esperienze in Eritrea e Sudan. La sua missione è stata costruire ponti: con i beduini del deserto, privati di acqua e diritti fondamentali, con israeliani e palestinesi che si incontravano per la prima volta non da nemici, ma da persone. «Quando si vede il volto dell’altro, si vede Dio», ripete. In un contesto di odio e vendetta, scegliere la via del perdono è forse la sfida più radicale. Layla lo sa bene. Un giorno incontrò un ex ufficiale israeliano che aveva compiuto gesti simili a quelli costati la vita a suo figlio. All’inizio non riusciva neppure ad ascoltarlo. Poi, vedendo le lacrime e il pentimento dell’uomo, trovò la forza di dirgli: «È molto difficile per me, ma ti perdono». Da allora ripete: «È facile parlare di pace, molto meno viverla. Ma il perdono è ciò che mi dà il coraggio di continuare». Tre storie, tre volti, un unico cammino. In un deserto che sembra senza fine, queste donne mostrano che la riconciliazione non è un’utopia. È un seme fragile, ma possibile, che nasce dal ventre ferito delle madri.
A «Chiese in Diretta», domenica 14 settembre su Rete Uno alle 8.30, le testimonianze complete.