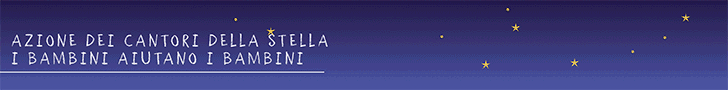di Cristina Uguccioni
Il 2025 è un anno speciale non solo perché ricorre il Giubileo ma anche perché tutta la cristianità celebra il 1700° anniversario del primo Concilio ecumenico della storia della Chiesa, convocato a Nicea nel 325 dall’imperatore Costantino. È un Concilio decisivo sia per l’impatto che ha avuto sulla storia del cristianesimo, sia per l’impatto che ancora oggi ha sulla fede di tutti coloro che si professano cristiani. Ne illustra i motivi – in questa conversazione con catt.ch e Catholica – monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e presidente della Commissione Episcopale per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della CEI.
Che cosa ha rappresentato nella storia del cristianesimo il Concilio di Nicea, cui furono invitati per la prima volta i vescovi di Occidente ed Oriente?
«Fu uno snodo fondamentale, decisivo. Il frutto di quell’incontro, infatti, è stato l’elaborazione del “Credo”, il Simbolo della nostra fede. Dopo l’epoca eroica dei martiri, in cui la fede era più testimoniata nella pratica che proclamata nelle parole, nel grande cambiamento d’epoca, veramente cruciale, seguito all’Editto di Milano del 313, che dichiarava il cristianesimo “religio licita” (culto ammesso), i cristiani divennero sempre più numerosi e dovettero trovare la bussola per dire ciò che è essenziale per la fede. Mentre sino ad allora ogni Chiesa locale aveva il proprio Simbolo, il proprio “Credo”, al Concilio di Nicea avvenne un fatto del tutto nuovo: l’elaborazione di un “Credo” con valore universale. Il “Credo” approvato dai 318 Padri di Nicea fu poi portato a compimento nel Concilio di Costantinopoli del 381: è il “Simbolo Niceno-costantinopolitano”, che noi professiamo ancora oggi la domenica durante la messa».
Perché Costantino volle convocare il Concilio?
«Divenuto imperatore unico, sentiva forte l’urgenza di assicurare l’unità politica anche attraverso la pace religiosa: il cristianesimo, che lui appoggiava e incoraggiava, si stava diffondendo. Vi erano tuttavia questioni aperte (le date diverse in cui si celebrava la Pasqua) e focolai di divisione, soprattutto nell’importante sede di Alessandria d’Egitto per lo scontro tra il vescovo Alessandro e il prete Ario. Quest’ultimo sosteneva che Gesù era solo una creatura “fuori serie”, un Dio di secondo grado, il primogenito della creazione, ma non il Figlio del Padre, Dio vero da Dio vero, uguale a Lui. Il pericolo era di vedere Gesù semplicemente come il profeta per eccellenza, un sapiente straordinario, ma non il Figlio che ci rivela e ci mette in contatto con la vita stessa di Dio. La minaccia toccava il cuore stesso della fede: Gesù non è solo un uomo esemplare o un saggio religioso! I Padri di Nicea, nel “Credo”, concordarono nell’affermare che Gesù è “della stessa sostanza (in greco “homooúsios”) del Padre”. Il pensiero eretico di Ario venne messo fuori gioco».
A suo giudizio nella nostra epoca quali articoli del “Credo” sono meno creduti e compresi? E ritiene che sia tornato a circolare lo spirito di Ario?
«Gli articoli meno creduti e compresi sono quelli escatologici riguardanti la vita eterna e la risurrezione della carne. Ma anche altri – riguardanti Gesù – sono esposti al rischio di non essere creduti in modo corretto. Lo spirito di Ario è tornato: potremmo parlare di neo-arianesimo. Persino molti cristiani, sensibili agli aspetti dell’umanità di Gesù di Nazaret, non riescono a credere che Egli sia l’unigenito Figlio di Dio, presente in mezzo a noi come il Risorto. Non riescono più a scorgere il volto del Figlio di Dio nell’uomo Gesù, nel quale riconoscono soltanto un essere umano, seppur eccezionale e particolarmente buono. Per questo il Concilio di Nicea era ed è ancora decisivo: esso dice che la divinità del Figlio non è alternativa alla sua umanità, ne è la radice. Il mio auspicio è che la celebrazione dell’anniversario del Concilio sia vissuta non formalmente e che dunque consenta – attraverso iniziative di approfondimento – di riscoprire e fare propria la grande confessione cristologica che i Padri di Nicea ci hanno consegnato. Da parte mia, ho voluto dedicare la mia Lettera Pastorale di quest’anno proprio al “Credo”».
Viviamo in un contesto culturale che dice in modo martellante di farsi da sé, essere autonomi, indipendenti da chiunque. Anche la fede rischia di essere pensata come atto personale slegato e indipendente da qualunque legame o vincolo. L’anniversario del Concilio di Nicea è importante anche perché offre l’occasione di fare memoria - leale, affettuosa e grata – di coloro che ci hanno consegnato la fede.
«Proprio così. L’atto di fede non può che essere personale, diventa però possibile solamente nella trama dei legami ecclesiali. La fede – come la vita – non ce la si dà: la si riceve. In quanto ereditata con un atto personale, diventa poi la mia propria fede. Prima ancora dei contenuti, il “Credo” ci dice che la fede ci viene consegnata all’interno di legami umani ed ecclesiali. Il “Credo”, nella formulazione elaborata dai Padri di Nicea, iniziava con il verbo al plurale: “noi crediamo in”. Noi possiamo credere solo nella sinfonia della nostra fede cristiana. La persona non è una entità separata dagli altri, ai quali decide – in un secondo tempo – se andare incontro o meno. L’identità di ogni persona passa attraverso gli altri, ed è mettendosi in gioco eticamente con gli altri, ossia attraverso tutte le forme della relazione pratica, che ciascuno comprende chi è. La persona è tale, dunque, perché è dentro una rete di legami. Se l’anniversario del Concilio lasciasse anche solo questo guadagno, ossia il recupero del carattere ecclesiale della fede – non alternativo ma inclusivo del carattere personale della fede – sarebbe già moltissimo».