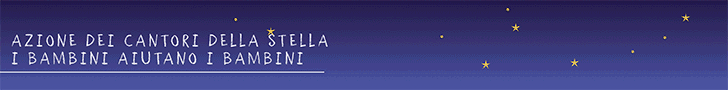Ricorre il 21 settembre, come ogni anno la terza domenica di settembre, la Festa federale di ringraziamento, penitenza e preghiera, detta anche Digiuno federale. Ne parliamo con Lorenzo Planzi, storico della Chiesa, ricercatore e libero docente all’Università di Friburgo, autore di un libro sulla storia della diplomazia tra Svizzera e Santa Sede, in uscita nei prossimi mesi nelle tre lingue nazionali.
di Gino Driussi per catt.ch e catholica/cdt
Quali sono le origini di questa ricorrenza, che è abbastanza particolare poiché è di carattere religioso ma ha radici politiche?
La sua storia comincia già nel 1517, quando un documento d’archivio attesta una “grande preghiera dei Confederati”. All’epoca la Confederazione non era uno Stato unico, ma un mosaico di Cantoni autonomi. In tempi di guerra, peste o carestia, le autorità politiche proclamavano abitualmente giornate di digiuno: pregare diventava un modo concreto per tenere unita la comunità. Nei Cantoni riformati, dal XVI secolo i digiuni si susseguirono, accompagnati spesso da collette per chi era in difficoltà. Anche i Cantoni cattolici introdussero tradizioni simili dal 1643. La prima Festa federale ufficiale arriva nel 1796, su proposta di Berna. Così nasce il Digiuno federale: un atto religioso che è anche politico, un gesto concreto di preghiera per rafforzare i legami civili nei momenti di crisi.
Come si è evoluta questa ricorrenza nel corso degli anni?
Per lungo tempo, cattolici e riformati la celebrarono in giorni diversi, come se ognuno avesse il proprio calendario di memorie e speranze. La svolta arriva nel 1832, quando la Dieta federale stabilisce la terza domenica di settembre come data condivisa. Tuttavia, i Grigioni la mantengono fino al 1848 il secondo giovedì di novembre, mentre Ginevra celebra ancora oggi il suo “Jeûne genevois”, come una bandiera della propria identità, il giovedì dopo la prima domenica di settembre.
Nel 1848 nasce il nuovo Stato federale. Si può dire che una ricorrenza come quella di cui stiamo parlando ha permesso di consolidare la pace religiosa e sociale che era ancora fragile in Svizzera?
Dopo il 1848, con la nascita dello Stato federale, le tensioni tra cattolici e riformati restano vive. Lo testimonia bene la chiusura della Nunziatura apostolica nel 1873, riaperta soltanto nel 1920. Il Digiuno federale diventa allora un’occasione per rinsaldare la convivenza: un giorno che ricorda a tutti quanto la pace religiosa e sociale sia fragile e preziosa. Le autorità cantonali continuano a regolamentare il digiuno, toccando aspetti morali, spirituali, sociali ed economici. Il cancelliere zurighese Gottfried Keller redige nuove regole dal 1863, mentre nel 1886 i vescovi pubblicano un regolamento valido per tutta la Svizzera cattolica. È un modo per ricordare che la fede riflette anche un tessuto sociale che tiene insieme la comunità.
In una società sempre più secolarizzata come la nostra, ha ancora senso celebrare questa ricorrenza, che ormai sembra sopravvivere soltanto sulla carta e che non dice più niente a buona parte della popolazione?
Oggi il Digiuno federale non è più così visibile, ma conserva un significato profondo. È un invito alla memoria, alla responsabilità e alla solidarietà. La dimensione religiosa resta viva nei culti ecumenici che si svolgono in ogni parte della Svizzera, compreso il Ticino, nei quali cattolici e riformati pregano fianco a fianco. Dal Concilio Vaticano II, la Festa assume un carattere sempre più ecumenico: diventa un momento per ricordare che la speranza può unire nei momenti di difficoltà.
La celebrazione ecumenica a Bellinzona
Come ogni anno, in occasione della Festa federale di ringraziamento e del “Tempo del Creato”, la Comunità di lavoro delle Chiese cristiane nel Canton Ticino organizza una celebrazione ecumenica cantonale. L’appuntamento è domenica 21 settembre, alle 16.30 nella chiesa evangelica riformata di Bellinzona (viale Stefano Franscini 1).