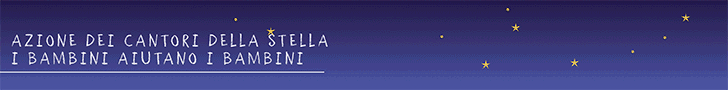da Buenos Aires Markus Krienke*
Fino alla sua ultima presa di posizione politicamente forte, quando il 10 febbraio ha scritto ai vescovi statunitensi la sua contrarietà nei confronti del «programma di deportazioni di massa» avviato negli Stati Uniti, Papa Francesco non si è mai stancato di sottolineare l’importanza della fratellanza universale come monito per la missione politico-sociale che spetta al cristiano oggi. Un messaggio che non a caso ha «riassunto» nuovamente nel suo ultimo incontro ufficiale avvenuto poco prima dell’Urbi et Orbi della Domenica di Pasqua di fronte al vice presidente americano Vance.
L’icona del Buon Samaritano
Il messaggio francescano di Bergoglio si incarna esemplarmente nella figura del Buon Samaritano che si è reso incondizionatamente prossimo di quel bisognoso per il quale nessun altro si sentiva in responsabilità. E non è un’ennesima conferma della sua «collocazione a sinistra» come spesso gli è stato rimproverato – non a caso dalla destra conservatrice (americana ma non solo) –, bensì la sua radicale interpretazione del Vangelo e del Concilio Vaticano II, che lo ha reso, nelle parole dell’arcivescovo di Buenos Aires Jose García Cuerva, «Padre di tutta l’umanità».
In queste parole troviamo riunito il profondo senso di lutto del «suo» popolo, quello argentino, che gli ha sempre rimproverato di non essere mai tornato in patria da quando era partito il 26 febbraio 2013 per il conclave che lo avrebbe eletto Papa, ma che ora non vuole mancare all’ultimo saluto, che gli si sta dando in tutto il Paese con la celebrazione di tantissime Messe.
Nel suo magistero, pieno di spirito profetico, che racchiude il sogno di una nuova umanità, il Papa è stato coraggioso, indicando due mali sociali che maggiormente caratterizzano le società liberali: permettere che si formino delle «periferie» sociali – fino a tollerare espressioni e atteggiamenti contro la dignità umana – e lo sfruttamento del pianeta, che mette in pericolo il futuro delle nuove generazioni. Francesco, al riguardo, ha parlato di «strutture di peccato», espressione di Giovanni Paolo II, per indicare quei meccanismi politici ed economici che non solo avvantaggiano ma anzi incentivano un agire collettivo a scapito di chi sta al margine e dell’ambiente. Bergoglio profila maggiormente, rispetto ai suoi predecessori, la finalità politica del bene comune come rimedio, ovvero la cura della «casa comune», tramite politiche di inclusione e di salvaguardia dell’ambiente. Così egli ribadisce ciò che ha formulato nella Laudato si’: «L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme», ossia in altre parole, i problemi sociali e quelli ambientali sono due facce della stessa medaglia. La proposta del Papa è per contro quella di una «ecologia integrale», indicata per dare un nuovo orientamento alla politica internazionale.
Avendo in questo modo integrato il rispetto per il creato nel cuore della stessa Dottrina sociale della Chiesa, e rendendolo un tema di giustizia sociale da cui la politica non dovrebbe prescindere, egli ha liberato la salvaguardia dell’ambiente e del clima dalla dialettica politica tra destra e sinistra, aprendo per il cristiano la possibilità di sostenerla, anche se animato da ragioni «conservatrici».
«No» alla «guerra giusta»
Il suo insistere sull’abolizione non solo della pena di morte (ribadita nel messaggio del 1° gennaio 2025) ma anche sul concetto di «guerra giusta» mira allo stesso obiettivo, spesso non compreso dalla diplomazia internazionale. Il suo radicale impegno per una pace che non si arrenda davanti alle difficoltà diplomatiche internazionali, è stato confermato dalla sua volontà di pregare per la pace in tutte le regioni del mondo, come all’ultimo Angelus della Domenica delle Palme. Questi segni particolarmente forti dimostrano come il Papa non si sia mai riconosciuto nei paradigmi della politica istituzionale, articolando piuttosto un monito profetico riguardo alle mancanze del mondo politico nei confronti dei poveri e degli emarginati. E proprio per questo Bergoglio era sommamente politico, e non aveva paura di denunciare anche radicalmente le ingiustizie prodotte dal capitalismo globale: «Questa economia uccide». Così, nella Fratelli tutti dichiara che «i politici sono chiamati a prendersi cura della fragilità dei popoli e delle persone». Proporre la «nonviolenza come stile di una politica di pace», come nel messaggio del 1. gennaio 2017, è espressione di una convinzione precisa di papa Francesco: che l’«amore sociale», ossia la forza della carità, può aiutare anche nelle vicende politiche a superare le differenze su ciò che è «giusto». Tuttavia, egli era anche consapevole che è difficile realizzare tale forza, indebolita oggi dalle nuove polarizzazioni del mondo. Per questo motivo, il Papa cercava una risorsa potente per la promozione della fratellanza universale nella collaborazione delle tre religioni abramitiche, ed esprimeva già nel 2020, nella Fratelli tutti, il suo timore che la «democrazia» e la «libertà» potessero essere strumentalizzate da poteri autocratici, i quali hanno gioco facile nella misura in cui le persone si comprendono come individui con qualche sentimento filantropico, ma non come fratelli e sorelle.
* Docente di etica sociale alla Facoltà di teologia di Lugano si trova in questo periodo in Argentina per un semestre accademico.