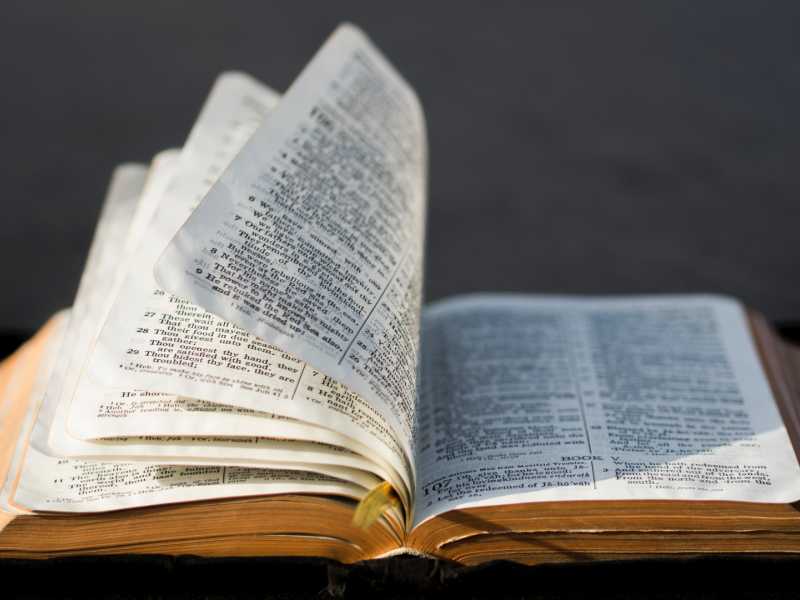di Laura Quadri
Il 27 agosto, presso la Facoltà di Teologia di Lugano, si svolge la Giornata di studi Biblical Wisdom and the Ethics of Eating: Ancient Values in Modern Food Debates. Come spiegano i promotori, scopo del Convegno è “esplorare come i principi biblici chiave – la tutela del creato e l'ospitalità – possano plasmare il dibattito contemporaneo sull'etica alimentare”. La seconda sessione sarà moderata dal prof. Marco Menon, a cui abbiamo posto alcune domande.
Professore, cosa intendiamo nello specifico per “etica del cibo”?
In linea di massima, nelle società occidentali consideriamo il cibo sempre più una questione di gusto individuale. Il giudice è il nostro palato. A volte subentrano considerazioni di salute, ma queste rientrano generalmente nell’ordine della necessità a cui dobbiamo adeguarci se vogliamo mantenerci in forma o guarire. In alcune realtà resiste ancora un legame tra cibo e tradizione, anche se tale nesso sembra essere legittimato più da ragioni di tipo commerciale che non da costumi tramandati di generazione in generazione. Intendo dire che spesso l’etichetta “tradizionale” applicata a determinati prodotti alimentari o piatti tipici è una formula di marketing, che può funzionare molto bene nel vendere qualcosa. Certo, in molti casi essa assume la forma di certificazioni atte a garantire il rispetto di determinati criteri qualitativi, e in questo senso – forse solo in questo senso – il nesso tra cibo e tradizione, per quanto trasformato e trasferito nell’ordine delle procedure, sopravvive ancora oggi. Ma per tornare alla questione iniziale, per quanto resti sempre vivo in alcuni di noi il ricordo di un pranzo domenicale in famiglia, o magari l’affettuosa immagine, tipicamente italiana, della nonna che prepara da mangiare, la questione del cibo e di come e cosa mangiamo è sempre più una questione individuale. Il giudice, ripeto, è il palato, e la dimensione è quella moderna, o iper-moderna, dell’individuo atomizzato e delle sue scelte soggettive in qualità di consumatore. Ma è proprio il fatto che il cibo sia ormai quasi totalmente una questione di scelta individuale, e non più di tradizione e comunità, dimensioni in cui vige l’istanza autorevole del costume tramandato e della condivisione, che rende urgente una considerazione etica delle nostre scelte. Oggi, infatti, possiamo avere tutti i cibi che vogliamo: non siamo più limitati nello spazio (abbiamo accesso a pietanze provenienti da tutti gli angoli del pianeta) e nemmeno dal tempo (non dipendiamo più dalla stagione per poter consumare i prodotti agricoli). Questa ampiezza di scelta, accompagnata dallo sfarinamento della forza orientante del costume, ha aperto un campo vastissimo alle considerazioni etiche nelle nostre scelte alimentari, mettendo al centro il fatto che il palato non dovrebbe essere l’unico giudice delle nostre scelte (eventualmente limitato dal medico).
È necessario, infatti, prendere in considerazione altri criteri, come l’impatto sociale e ambientale, la sostenibilità, la qualità, il benessere nostro e degli animali non umani.
L’etica del cibo e l’etica del mangiare studiano i criteri che orientano le nostre scelte, muovendosi al di là della “tirannia del palato”, cercando di comprendere, in uno sguardo più ampio, non limitato alla nostra esperienza immediata, le molteplici implicazioni che ogni nostra singola scelta alimentare ha su ciò che ci circonda.
Sapienza biblica e cibo: perché questo tema, nel contesto attuale?
L’idea di organizzare un convegno su questo tema, e di concentrare l’attenzione sulla dimensione della “saggezza biblica” in un contesto interreligioso nasce come risposta a una domanda. Come dicevo prima, la riflessione etica che si è sviluppata negli ultimi decenni in materia di etica del cibo e etica del mangiare abbraccia davvero tutti gli aspetti dell’esperienza, toccando questioni di etica animale, etica ambientale, proponendo anche visioni spirituali integrali. Ma l’impressione è che si tratti di riflessioni e sistemi filosofico-morali profondamente radicati nelle categorie del pensiero moderno, ovvero caratterizzati da una centralità dell’individuo, oppure da una sorta di “dicotomia” quasi inconsapevole che separa gli esseri umani dal resto del mondo naturale e delle creature viventi. Una dinamica paradossale, se vogliamo, perché proprio nel tentativo di recuperare una presunta “unità perduta” sul piano morale ed esistenziale, la si riafferma costantemente. Ci siamo quindi resi conto tuttavia che, nel dibattito etico e morale sul cibo e sul mangiare, sono ancora presenti elementi teorici appartenenti a una matrice differente, che “precedono” la dicotomia e l’individualismo tipicamente moderni, e che sembrano piuttosto orientati a un pensiero relazionale.
Intendo dire che quando consideriamo il cibo in una prospettiva etica, non dobbiamo fissarci in modo astratto sul “prodotto”, ma pensarlo in una rete di relazioni.
L’atto del mangiare non è una azione puntuale che riguarda solo me e le mie scelte; non è meramente l’inevitabilmente violento atto della distruzione di un ente che viene assimilato dal mio organismo – che lo si voglia o no, mangiar (consumare) è sempre un atto che implica la distruzione di qualcosa a vantaggio di qualcos’altro. Mangiare è sempre un atto relazionale, e intenderlo come tale significa collocarlo correttamente in una rete di cui facciamo già da sempre parte: relazioni che ci precedono e anticipano, relazioni che creiamo e diffondiamo. Da un punto di vista filosofico (ecco il nesso con la saggezza biblica) una tale impostazione teorica ha un forte legame con la tradizione ebraico-cristiana, al cui centro sta appunto la relazione. Il convegno intende affrontare, in una prospettiva interreligiosa e interdisciplinare, in dialogo tra filosofie e teologie, la presenza di queste categorie nel dibattito attuale, che a nostro parere rappresentano una risorsa fondamentale per bilanciare, ed eventualmente correggere, la dicotomia e l’individualismo di cui sopra.
Quali elementi di riflessione offrono le Sacre Scritture sul cibo? Ci sono dei testi specifici su cui ci si può soffermare?
Come ha osservato Adriano Fabris nel suo recente volume Etica delle relazioni alimentari (Springer, 2024), la prima norma che gli esseri umani ricevono da Dio nel libro del Genesi è di natura alimentare: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti” (Gn 2, 16-17). Al di là di tutte le considerazioni che si possono fare su questi versetti fondamentali, ne possiamo trarre, per il tema che ci interessa ora, un’indicazione di base: non è lecito mangiare tutto ciò che è commestibile. In altre parole, vi sono dei limiti normativi che stabiliscono cosa dobbiamo e non dobbiamo mangiare. In senso generale credo che la Scrittura fornisca anzitutto l’idea, appunto, del limite. Questa nozione illumina una distinzione altrettanto fondamentale, sempre discussa da Fabris nel suo saggio: quella tra bisogno e desiderio. Un bisogno lo possiamo soddisfare: se abbiamo fame, possiamo saziarci, e per un po’ di tempo il bisogno è acquietato. Esso è costitutivamente legato alla nostra sopravvivenza e, se non dovessimo porre rimedio al pungolo del bisogno, finiremmo inevitabilmente col deperire e morire. Il desiderio, invece, è un’apertura all’infinito che, in linea di principio, è impossibile soddisfare: esso è per definizione inappagabile. Si vede così la doppia dimensione del cibo e dell’atto del mangiare, che è tanto naturale (dimensione del bisogno) quanto simbolica e culturale (dimensione del desiderio). Il limite cui facevo riferimento prima, e che mi sembra essere il vero messaggio di quel passo biblico, è un limite posto al desiderio essenzialmente inappagabile che caratterizza l’essere umano. Siamo tutti consapevoli di come un desiderio lasciato a briglia sciolta possa essere distruttivo. Nella misura in cui, nella modernità, ogni discorso religioso è stato neutralizzato, è stato anche neutralizzato, de facto, il limite indicato dal quel “primo comandamento”. Certamente si sono ripetuti i tentativi puramente filosofici di stabilire un limite al desiderio: è appunto il compito dell’etica del cibo e del mangiare. Ma qui sorge una domanda: se un limite liberamente posto dall’essere umano non possa, in fondo, essere da questi altrettanto liberamente eliminato. I limiti posti su base puramente convenzionale dagli esseri umani sembrano perdere la loro forza normativa, suggerendoci di cercare altrove. Ma questo è il dramma della nostra epoca, perché proprio la filosofia negli ultimi cent’anni ha svuotato di senso tutte le strutture che in precedenza offrivano un orientamento.
Cosa auspica per i partecipanti alla Giornata?
I relatori di questo convegno sono studiosi di fama internazionale, provenienti da università europee e asiatiche, con un solido background nelle discipline filosofiche e teologiche. Lo spirito con cui è stato pensato questo evento è di natura interdisciplinare, nel senso che cercheremo una vera e propria contaminazione di metodi e approcci provenienti da vari campi della filosofia e della teologia, e soprattutto – in linea con il Master dell’Istituto ReTe, che si occupa di dialogo interreligioso – ha una decisa matrice interreligiosa. Per quanto l’oggetto della discussione siano le categorie della saggezza biblica, la prospettiva non è confessionale, ma interreligiosa: ciò significa che tali categorie verranno tematizzate in maniera inclusiva e comparativa. Non so dire in anticipo cosa emergerà dalla discussione tra i relatori e con il pubblico; mi auguro però che un evento del genere possa contribuire, da un lato, a focalizzare gli aspetti più problematici delle nostre pratiche alimentari e delle relative riflessioni etiche al centro del dibattito; dall’altro, a mettere in evidenza come il pensiero biblico rappresenti una risorsa, e non un elemento divisivo, spendibile nel discorso pubblico.
Il programma completo dell’evento: Biblical Wisdom and the Ethics of Eating: Ancient Values in Modern Food Debates | USI - Facoltà di Teologia di Lugano