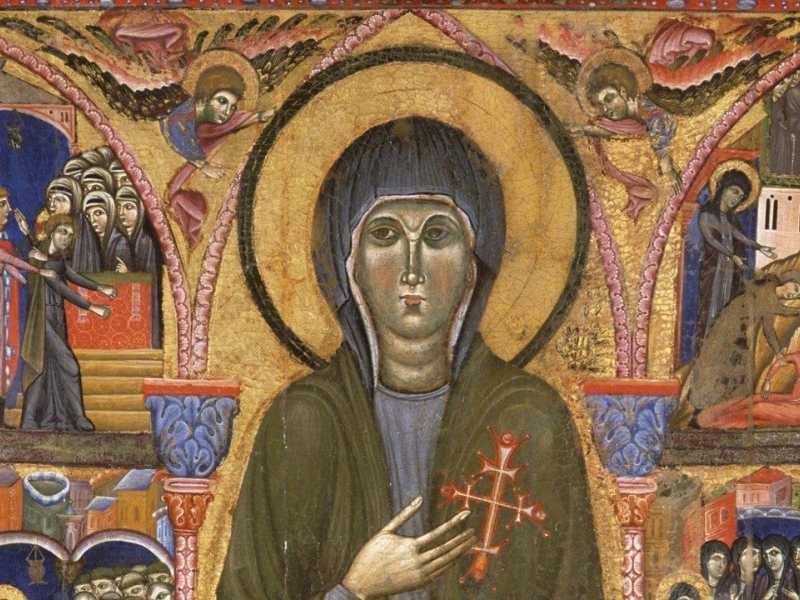di Cristina Uguccioni
Sessant’anni fa, l’11 ottobre 1962, si apriva il Concilio Vaticano II. Come ha scritto Benedetto XVI, «grandi cose dovevano accadere. I concili precedenti erano stati quasi sempre convocati per una questione concreta alla quale dovevano rispondere. Questa volta non c’era un problema particolare da risolvere. Ma proprio per questo aleggiava nell’aria un senso di attesa generale: il cristianesimo, che aveva costruito e plasmato il mondo occidentale, sembrava perdere sempre più la sua forza efficace. (…) La percezione di questa perdita del presente da parte del cristianesimo e del compito che ne conseguiva era ben riassunta dalla parola aggiornamento».
In occasione di questo anniversario dialoga con catt.ch e Catholica l’arcivescovo Agostino Marchetto: definito da papa Francesco «il migliore ermeneuta del Concilio Vaticano II», mons. Marchetto è autore, fra gli altri, dei volumi «Il Concilio ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia» e «Il Concilio ecumenico Vaticano II. Per una sua corretta ermeneutica» (editi dalla Libreria editrice vaticana).
Cosa ha rappresentato il Concilio Vaticano II nella storia della Chiesa?
Il Magno Sinodo fu, per la Chiesa, un avvenimento straordinario: vi parteciparono 3.068 padri, provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo. Dall’11 ottobre 1962 all’8 dicembre 1965 si svolsero 168 congregazioni generali e 10 sessioni pubbliche. Furono promulgati 16 documenti: 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni. La vastità dell’impegno cui si dedicò la Chiesa è ben rappresentata dagli Atti ufficiali del Concilio: 62 grossi volumi. Nel Concilio Vaticano II, per dirla con una immagine efficace, tradizione e rinnovamento (riforma, si può anche dire) si sono abbracciati «nella continuità dell’unico soggetto Chiesa», come ha ben osservato Benedetto XVI: il Concilio Vaticano II non ha dato vita a un’altra Chiesa.
Può formulare un esempio di rinnovamento nella continuità che lei giudica particolarmente significativo?
Un esempio è il tema della collegialità episcopale e del primato pontificio, colonne portanti dell’essere Chiesa nel mondo e per il mondo. Mentre il Concilio Vaticano I, pur riconoscendo la collegialità episcopale, sembrava quasi sottolineare la solitudine papale, il Concilio Vaticano II ha approfondito e condotto al giusto equilibrio il rapporto tra il collegio apostolico e il successore di Pietro, al quale Gesù disse: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa.
Quale ritiene sia la maggiore eredità del Concilio?
Vi sono molti frutti prodotti dai documenti del Concilio, ma ritengo che la grande eredità che abbiamo ricevuto sia il dialogo. Durante quello straordinario evento ecclesiale si decise di percorrere la strada del consenso e del dialogo per coniugare tradizione e rinnovamento. Come insegna la storia dei sinodi, l’assenza o la carenza di consenso si paga a caro prezzo. L’esempio di molti Concili importanti (da quello di Calcedonia al Concilio di Trento al Vaticano II), che si sono preoccupati di raggiungere faticosamente il consenso, testimonia la grande rilevanza del consenso e il suo carattere di «segno» in quanto la verità non viene decisa mediante votazione, ma attestata mediante il consenso. E qual è la strada per raggiungerlo se non quella del dialogo? Le difficoltà per la stesura della costituzione Gaudium et Spes furono superate quando arrivò - davvero provvidenzialmente - l’enciclica Ecclesiam suam di papa Paolo VI, che conferiva deciso impulso allo stile del dialogo, proposto come l’atteggiamento più adatto a connotare la forma della comunicazione cristiana della fede e nella fede. Ritengo che oggi nella Chiesa il dialogo intraecclesiale sia una necessità grande. Bisogna tornare a dialogare: non si può essere cristianamente l’uno contro l’altro armati.
Quali sono i semi del Concilio che ancora attendono di giungere a completa maturazione?
Papa Paolo VI affermava con forza la necessità del dialogo con il mondo contemporaneo. Scriveva: «La Chiesa deve venire a dialogo con il mondo in cui si trova a vivere; la Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio». Oggi nella Chiesa abbiamo raccolto e fatto nostro questo appello al dialogo con tutti gli uomini e le donne del mondo, ai quali desideriamo andare incontro.
Bisogna però ricordare che papa Paolo VI con altrettanta forza affermava che il dialogo deve restare immune da un relativismo che intacchi la dottrina della fede e della morale. Diceva: «La sollecitudine di accostare i fratelli non deve tradursi in un’attenuazione, in una diminuzione della verità»; «il nostro dialogo non può essere una debolezza rispetto all’impegno verso la nostra fede». Al Concilio, durante una seduta della commissione preparatoria della Gaudium et spes il giovane vescovo Karol Wojtyla rammentò a tutti che senza croce, senza il mistero di morte e risurrezione di Cristo, non v’è cristianesimo».