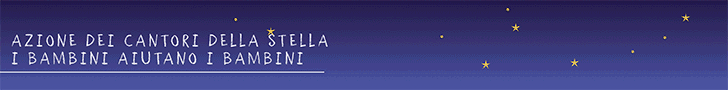di Cristina Vonzun
È l’Enciclica sicuramente più ecologica della storia della Chiesa. Papa Francesco l’ha scritta nel terzo anno di pontificato e l’ha firmata il 24 maggio 2015. Ma la parola «ecologia» non deve trarre in inganno. Il testo va oltre con quell’aggettivo «integrale» che il Papa piazza nel titolo del capitolo IV della Laudato si’. Francesco lancia così un preciso messaggio di preoccupazione non solo per la natura, ma anche per gli uomini, terre e persone maltrattate, sfruttate e scartate. Chiede impegno per la «casa comune» e per l’accesso di tutti alle risorse. Da allora sono trascorsi 10 anni. In Ticino se ne è parlato tanto, anche grazie al lavoro portato avanti dalla Rete Laudato si’, che a quell’Enciclica si ispira. Nata nel 2020, oggi aggrega 14 realtà laicali ticinesi che si ispirano all’etica sociale cattolica. Realtà attive e complementari nel loro agire, da Caritas Ticino con il sociale e l’agricoltura rispettosa dell’ambiente, alle ACLI con emigrazioni e lavoratori, ad Azione Quaresimale attiva nei progetti di sviluppo al Sud, all’UCIT (Unione imprenditori cristiani ticinesi) e all’OCST, per nominare solo alcune. «La Rete propone da 4 anni, a tardo autunno, il Festival della dottrina sociale, un appuntamento che porta testimonianze concrete, sia di realtà interne alla Rete sia di realtà esterne. A fine estate invece c’è la Summer school. Qui il taglio è più accademico», ci spiega Daria Lepori, del comitato della Rete Laudato si’. Ma non solo. «Nel 2023, in occasione dell’iniziativa per i Ghiacciai, abbiamo proposto come Rete qualcosa di più specifico. Siamo andati a Mezzana per lavorare sul significato dell’acqua nel nostro territorio. Non c’erano ancora stati i gravi disastri dell’estate del 2024 ma comunque era vivo il caso dell’inquinamento del pozzo polenta a Morbio Inferiore». Attività concrete che hanno coinvolto la società civile e la gente comune. Diverso è il discorso della relazione tra le proposte della Rete e le parrocchie. «La Summer School si svolge in alta valle Blenio, mentre il Festival è nel luganese, tuttavia mi pare che le nostre proposte restino soprattutto legate a persone sensibili mentre il tessuto parrocchiale vero e proprio, è un po’ distante. Abbiamo comunque singoli parroci che partecipano. Va detto però che in un territorio piccolo come la Svizzera italiana, Caritas Ticino assume pienamente il tema e ha addirittura creato un Centro nel Piano di Magadino, diventando un po’ il faro a livello locale». Daria Lepori ci anticipa anche il tema della prossima Summer School e del Festival di fine autunno che sarà: «La Speranza che prende forma per cambiare il corso della storia – Piste d’azione nel tempo (kairos) del Giubileo 2025, del 10° anniversario della Laudato Si’ e di grandi incertezze». Ricordiamo infine che Caritas Ticino, il 27 settembre organizzerà un convegno dedicato alla Laudato si’ presso l’omonimo Centro di Ecologia Integrale a Sant’Antonino.
In libreria: per una fede che cura l’ambiente
«Creatore di tutte le cose» si legge nel simbolo niceno, espresso nel 325 d.C. dal Concilio ecumenico. Su questo aspetto della confessione cristiana si sofferma un libro di Simone Morandini, teologo e studioso di etica ambientale: «Credo in Dio, fonte di vita. Una fede ecologica» (Bologna, EDB, 2025). La fede nell’atto creativo del Dio trino apre la via a una prospettiva ecologica per il nostro tempo e per la cura dell’ambiente. Il Credo recitato a Messa affonda le sue radici nel Simbolo niceno, espresso 1700 anni fa, e nel suo ampliamento legato al Concilio di Costantinopoli del 381, il cosiddetto Simbolo niceno-costantinopolitano. L’autore ha ritenuto importante inoltrarsi dentro i testi biblici, recuperando un elemento sottovalutato da una parte della teologia novecentesca. «La confessione di Dio in quanto Creatore è forse uno dei temi divenuti più problematici nel tempo della scienza», riflette Morandini. «È come se, ci dice in maniera un poco ingenua molta divulgazione scientifica, il fatto di comprendere i meccanismi tramite i quali si realizzano le dinamiche del mondo, ci consentisse di lasciare sullo sfondo l’origine fondante della realtà tutta, dei meccanismi stessi che la scienza studia». La teologia della Creazione ci permette di recuperare la possibilità di parlare del Creatore nel tempo della scienza, ed è una delle sfide portate avanti nel libro. «Ritrovare questa dimensione della fede cristiana come possibile, confessabile, praticabile – conclude lo studioso – significa anche guadagnare uno sguardo profondo sul mondo, capace di illuminarne il senso, come realtà buona, meritevole di cura, preziosa».