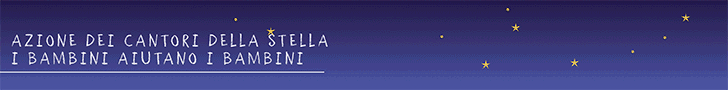di André Marie Jerumanis*
Leone XIV eredita da papa Francesco una Chiesa segnata da numerosi cambiamenti, sfide e direzioni pastorali che hanno definito il suo pontificato dal 2013 in poi. Ecco alcuni elementi principali della Chiesa ereditati da Francesco.
Una Chiesa più sinodale
Papa Francesco ha promosso con forza la sinodalità, cioè una Chiesa che ascolta, cammina insieme e prende decisioni in modo più collegiale. Il processo del Sinodo sulla sinodalità (2021–2024) è una delle sue eredità più forti, puntando a rendere la Chiesa meno clericale e più partecipativa.
Una Chiesa più missionaria, in uscita
Una Chiesa che evangelizza non con proselitismo ma con la forza d’attrazione di una testimominaza gioiosa. Il richiamo a orientarsi innazittuto a Cristo, centrando l’annucio sull’amore e la misericordia (Dilexit nos), evitando lo spirito mondano che è il peggiore dei mali che può accadere alla Chiesa. La descrizione delle 15 malattie della curia romana è uno specchio per rinnovare nella santità la Chiesa.
Una Chiesa povera e per i poveri
Il suo stile sobrio e il suo richiamo costante alla solidarietà con gli emarginati secondo il paradigma del buon samaritano hanno riorientato l'attenzione della Chiesa verso le periferie esistenziali, economiche e geografiche.
Riforma della Curia
Con la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium (2022), Francesco ha riorganizzato la Curia Romana per renderla più al servizio delle Chiese locali e della missione evangelizzatrice.
Attenzione alla crisi climatica e alla giustizia sociale
Encicliche come Laudato si’ (2015) e Fratelli tutti (2020) hanno reso la Chiesa un attore centrale nel dibattito globale sui temi dell’ecologia integrale, della pace e della fratellanza universale. La terza guerra mondiale a pezzi, denunciata da Francesco, si avvera sempre più. Il disordine mondiale generato da visioni sociopolitiche sempre più egoistiche, interpellano il messaggio profetico del Vangelo che il nuovo papa deve portare avanti.
Una Chiesa più aperta al dialogo
Il Papa ha promosso il dialogo ecumenico e interreligioso, in particolare con l’Islam (storico il Documento di Abu Dhabi del 2019), e un approccio più inclusivo verso divorziati risposati e persone LGBTQ+, pur senza modificare la dottrina tradizionale. Queste aperture sono state interpretate in diversi modi, spesso non secondo l’intenzione del papa stesso, sucitando incomprensione e rifiuto da una parte, o attese illusiorie che vanno al di là di ciò che il suo magistero pastorale indicava.
Sfide complesse
Non possiamo ignorare che il nuovo Papa erediterà anche sfide complesse: basta pensare alla crisi degli abusi sessuali, che Francesco ha affrontato con corraggio e umilità; non possiamo non vedere una polarizzazione ecclesiale interna tra progressisti e tradizionalisti, che rappresenta una minaccia per la comunione ecclesiale, in contradizione con la volontà di Cristo stesso, una polarizzazione che deriva da una ermeneutica diversa del Concilio ecumenico Vaticano II, che va da un rifiuto più o meno esplicito, fino a una relativizzazione dei scritti conciliari per richiamarsi solo allo spirito del concilio; è da rilevare un rapporto teso con alcuni ambienti tradizionalisti, specialmente dopo le restrizioni alla Messa in latino (Traditionis custodes), restrizioni giustificate secondo il papa (Responsa ad dubbio); non si può anche passare sotto silenzio la carenza di vocazioni e il problema di una formazione adeguata del clero che richiede iniziative nuove; la secolarizzazione crescente e un materialismo edonistico sono difficoltà per comunicare un messaggio che salva in un contesto sempre più scristianizzato, ma non per questo senza aspettare una parola ecclesiale che orienta; emerge sempre di più un’attesa di supplemento di senso, di umanità, ma anche di trascendenza, alla quale la Chiesa deve rispondere in modo adeguato; il ruolo della donna nella Chiesa che il papa Francesco ha cercato a valorizzare rimane da interpretare; una situazione di persecuzione dei cristiani nel mondo che è in crescita con più di 300 mila l’anno scorso.
*prof. di teologia morale alla Facoltà di teologia di Lugano e membro della Pontificia Accademia di teologia