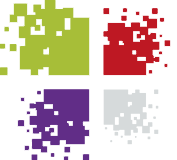di Cristina Uguccioni
Edito da Il Mulino, “Macchine celibi” è un brillante, acutissimo saggio firmato da due intellettuali di vaglia, Chiara Giaccardi e Mauro Magari, sociologi, docenti all’Università Cattolica di Milano. Nel volume viene presentata una lucida analisi della nostra epoca, un’epoca nella quale «tutto è connesso, ma diventa impossibile intendersi. Tutto funziona, ma siamo travolti dalle crisi. Tutti siamo liberi, ma nessuno sa come cambiare le cose». È tempo di riflessione e azione, sostiene Chiara Giaccardi dialogando con Catholica e catt.ch.
Chi sono le “macchine celibi”?
«L’ispirazione è venuta riflettendo sull’automatizzazione della vita che l’intelligenza artificiale sta spingendo in maniera potentissima: ci siamo rammentati dei surrealisti che parlavano di macchine celibi, congegni efficienti che però giravano a vuoto: emblema di tali macchine è l’opera di M. Duchamp, il “Grande Vetro”. Riteniamo che essa sia una potente metafora per interpretare la contemporaneità. L’opera mostra due piani immanenti, che non comunicano fra di loro. Nella parte sottostante vi sono i “celibi”, rappresentati come pistoni, congegni meccanici che si muovono in maniera efficiente ma senza scopo. Nella parte superiore vi è la donna, un’entità irraggiungibile rappresentata come un oggetto di desiderio. I “celibi” si muovono in un ciclo infinito, ciascuno solo, col suo movimento meccanico continuo, che però non raggiunge mai lo scopo».
Scrivete: «Proprio come “i celibi” del “Grande Vetro” cerchiamo autenticità, ma finiamo isolati e assorbiti da un sistema che ci vuole funzionanti: un’associazione di persone addestrate in modo omogeneo all’individualismo». Quali espressioni ha questo fenomeno? E quali conseguenze?
«Oggi nulla rimane estraneo alla razionalizzazione digitale. Il che significa che ogni sfera della vita è sottoposta alla logica del funzionamento, della misurazione, della standardizzazione. La razionalizzazione digitale provoca processi di frammentazione, ottimizzazione, pressione ad essere performativi, che causano disagi psicologici anche pesanti sugli adulti e sui giovani. Viviamo una situazione in cui l’individuo, immerso in un’offerta apparentemente infinita e stimolato continuamente alla ricerca del godimento, si sente costretto a cogliere ogni chance. Il paradosso sta nel fatto che siamo “obbligati” a stare bene, ad avere successo, a realizzarci. E quando ciò non succede, il peso del fallimento personale e il giudizio sociale diventano schiaccianti. La sterilità sociale non è semplicemente la denatalità, ma l’incapacità di uscire dalla logica performativa che fa agire in maniera compulsiva senza che ciò si traduca in senso per l’esistenza. E così, più si diventa macchine celibi più si è incapaci di affrontare la questione dell’alterità».
Questo libro non è contro la tecnica, da voi paragonata a un farmaco.
«Proprio così: la tecnica è come un farmaco, e dei farmaci non si può fare a meno perché salvano le vite, anche sul piano sociale. Se non vi fosse stato il digitale non saremmo sopravvissuti al lockdown. Però è fondamentale prendere coscienza del fatto che esiste anche la dimensione tossica del digitale. E occorre contenerla il più possibile».
Come ottenere un reale, benefico contenimento?
«Noi riteniamo – è la tesi del libro – che sia necessario recuperare quella dimensione dell’umano che nella tecnica non trova spazio: la dimensione dello spirito. Questa strada non è espressione della nostalgia del bel mondo perduto. È strada che costruisce il futuro. Lo spirito è una categoria molto ampia, include la religione, ma non si esaurisce in essa: infatti comprende la capacità umana di meravigliarsi e contemplare, il senso della bellezza, la dimensione emotiva ed empatica: comprende tutto ciò che non può essere ridotto a dato e quindi non può essere automatizzato. Nell’era delle macchine celibi vanno coltivati i percorsi di deautomatizzazione che ci rendono liberi appunto dal grande ingranaggio, dalla trappola del Grande Vetro».
Come descriverebbe la figura dei poeti sociali che voi indicata come l’alternativa alla macchine celibi?
«Poeti sociali sono tutti coloro che riescono a recuperare la dimensione non automatizzabile della vita umana. L’ultima parte del nostro volume è dedicata a esplorare la dimensione poetica, che è lingua della speranza. Per poesia ovviamente non si intende un genere letterario ma quello sguardo sulla realtà che non è meramente estrattivo, utilitaristico, strumentale e a servizio della sovranità dell’io. È uno sguardo che tiene conto della verità scientifica che la biologia e la fisica ci consegnano: tutto è legato a tutto, non esiste alcuna entità che sussista slegata dalle altre. Questa evidenza empirica circa la materia riguarda anche gli essere umani e ha precise implicazioni. Il nostro non è un discorso etico ma socio-antropologico che parte da questa verità scientifica e chiede di riconoscere e promuovere inseparabilmente la dimensione dello spirito e della relazione».
Quale azione si rende dunque necessaria?
«Direi una duplice azione: bisogna lavorare sul piano culturale affinché la dimensione dello spirito e della relazione sia riconosciuta e recuperata nel suo valore, e occorre scoprire, valorizzare e mettere in contatto tra loro tutte quelle esperienze che testimoniano un modo diverso di agire, non individualistico, non estrattivo, non autosufficiente: esistono migliaia di persone, gruppi, associazioni, imprese che operano non secondo la logica dell’automatizzazione e del celibato macchinico, bensì nella logica dell’interdipendenza, dello spirito, della libertà che si esercita nel legame. Sono l’eredità bella che possiamo consegnare alle giovani generazioni».