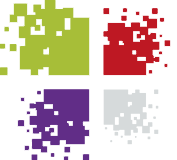Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, per Nicolò Govoni, non è solo una passerella di simboli. È una lente di ingrandimento: sulle cause, sulle contraddizioni, e su una domanda che taglia in due ogni grande cerimonia. A che cosa serve, davvero, un gesto se non produce conseguenze misurabili?
Quando sfila come portabandiera della bandiera olimpica, accanto a figure di “calibro” internazionale, Govoni non nasconde l’emozione. Ma sposta subito il fuoco. «Va bene essere riconosciuti come simboli… però poi questo, come cambia il domani? Perché se non c’è un livello misurabile, allora è veramente una cerimonia, uno show». È qui che si innesta il suo punto: quel momento deve “dare stile” e sostanza a cause concrete. «Per me è importante che questo momento abbia dato una amplificazione e che il tema dell’istruzione d’eccellenza gratuita possa risuonare», dice.
Oltre il simbolo: il sogno dell’istruzione d'eccellenza
Il primo messaggio che vorrebbe far arrivare, soprattutto ai più giovani, è diretto e anti-elitario: «La mia presenza alla cerimonia sia la prova tangibile che un sogno si può sempre realizzare». E insiste nel rovesciare una narrazione: «Non bisogna essere figli di… avere una grande fortuna in banca per riuscire a fare qualcosa che ti risuona». Non è retorica motivazionale, sostiene; è la possibilità che un ragazzo davanti alla TV pensi: se può farlo lui, «lo posso fare anch’io».
Il secondo messaggio riguarda l’idea di eccellenza. Govoni rivendica che si può arrivare in uno stadio, su un palcoscenico globale, anche “facendo istruzione”. Un campo che non è sempre stato considerato “sexy”, ammette: «Quando ho cominciato otto anni fa nessuno pensava che fosse particolarmente… wow fare istruzione». Eppure, proprio lì vede la svolta: trasformare qualcosa che appare “semplice” in un progetto sofisticato, capace di produrre futuro.
Ridefinire la pace e l'incontro con i campioni
Il tema della pace, inevitabile quando si sventola una bandiera olimpica, per lui è tutt’altro che semplice. Diffida delle definizioni ridotte a slogan: «Quando si sventola la bandiera arcobaleno spesso e volentieri si riduce la pace a “non guerra”». E incalza: se le armi tacciono per qualche anno e poi la violenza riparte, «allora non era pace». Porta un esempio che definisce lampante: Israele-Palestina, un conflitto che “continua a riaccendersi” e che rende fragile ogni formula consolatoria.
La sua definizione, invece, è una triade: «Per me la pace è consapevolezza, identità e libertà». Consapevolezza come conoscenza delle proprie radici; identità come capacità non solo di “sapere chi si è”, ma anche di affermarlo; libertà come condizione senza la quale la pace non regge. Qui Govoni prende posizione su un terreno scivoloso: l’identità culturale non è per lui un tabù, e anzi prevede che diventerà sempre più centrale anche in Europa, con polarizzazioni e reazioni “conservatrici” legate alla percezione di erosione culturale. Un passaggio controverso, ma coerente con la sua idea: senza popoli che si sentono liberi e riconosciuti, la pace resta una pausa, non un processo.
Nella cornice dei portabandiera, Govoni racconta anche gli incontri, quelli che possono diventare racconto educativo per i suoi studenti. Con il maratoneta keniano Eliud Kipchoge (che descrive come “leggendario”), dice di aver fatto una cosa molto semplice e molto concreta: l’invito. «L’ho invitato a venire a vedere la scuola», perché per molti ragazzi sarebbe come vedere materializzato un sogno. È il suo modo di collegare l’eccezionalità dell’evento al quotidiano di un’aula scolastica.
Poi c’è Cindy Ngamba la prima medaglia d’oro del “Refugee Team”, la squadra olimpica che offre un’“affiliazione” sportiva a chi non ha una nazione riconosciuta o un legame legale spendibile. Govoni ne coglie la portata simbolica e pratica insieme: «Penso che questo possa dare una speranza a tutti quei bambini e ragazzi che ho accolto a scuola e che hanno l’etichetta a vita di “rifugiati”. Proprio per questo l’esempio, dice, è potente: arrivare a quei livelli “nonostante” il percorso.
La sfida al sistema e il ritorno alla realtà
Il capitolo più critico emerge quando parla di ONU e UNHCR, anche per la presenza di Filippo Grandi tra i portabandiera. Govoni premette che non c’era un rapporto pregresso: «Non ci conosceva». Ma la sua valutazione sul sistema resta coerente con la genesi e lo sviluppo di Still I Rise (organizzazione che non accetta donazioni da istituzioni e agenzie governative o sovranazionali): «Sono molto critico dalle Nazioni Unite perché trovo che siano un sistema obsoleto». Elenca segnali di perdita di peso e di efficacia, fino a una previsione netta: «Per come sono fatte oggi verranno dissolte nei prossimi trent’anni… e poi nascerà qualcos’altro».
Eppure, dentro la critica istituzionale, salva l’umano. Di Grandi dice di aver visto «una persona di cuore», partita “da volontario” e desiderosa, ora, di tornare a un volontariato diretto “uno a uno”. Il problema, per Govoni: «È il sistema a essere un problema». Un macchinario che “mantiene se stesso” e finisce per disattivare anche chi vorrebbe riformarlo.
Resta l’ultima scena, forse la più tenera e rivelatrice: l’attesa della reazione dei suoi studenti. In Kenya la cerimonia non era facilmente accessibile in diretta, per fuso orario e diritti tv, così la visione arriva nella Scuola in queste ore in streaming. Govoni lo dice con un’energia trattenuta: è «molto elettrizzato» all’idea che i ragazzi vedano quel frammento di mondo e possano sentirlo vicino.
In fondo, la sua scommessa è tutta qui: usare l’eccezione (un giro di pista, una bandiera, un grande stadio) per dare forza all’ordinario che cambia le vite: una scuola, una lezione, un’opportunità gratuita ma d’eccellenza. E farlo senza rifugiarsi nella metafora. Perché, come ripete, i simboli contano solo quando diventano realtà.